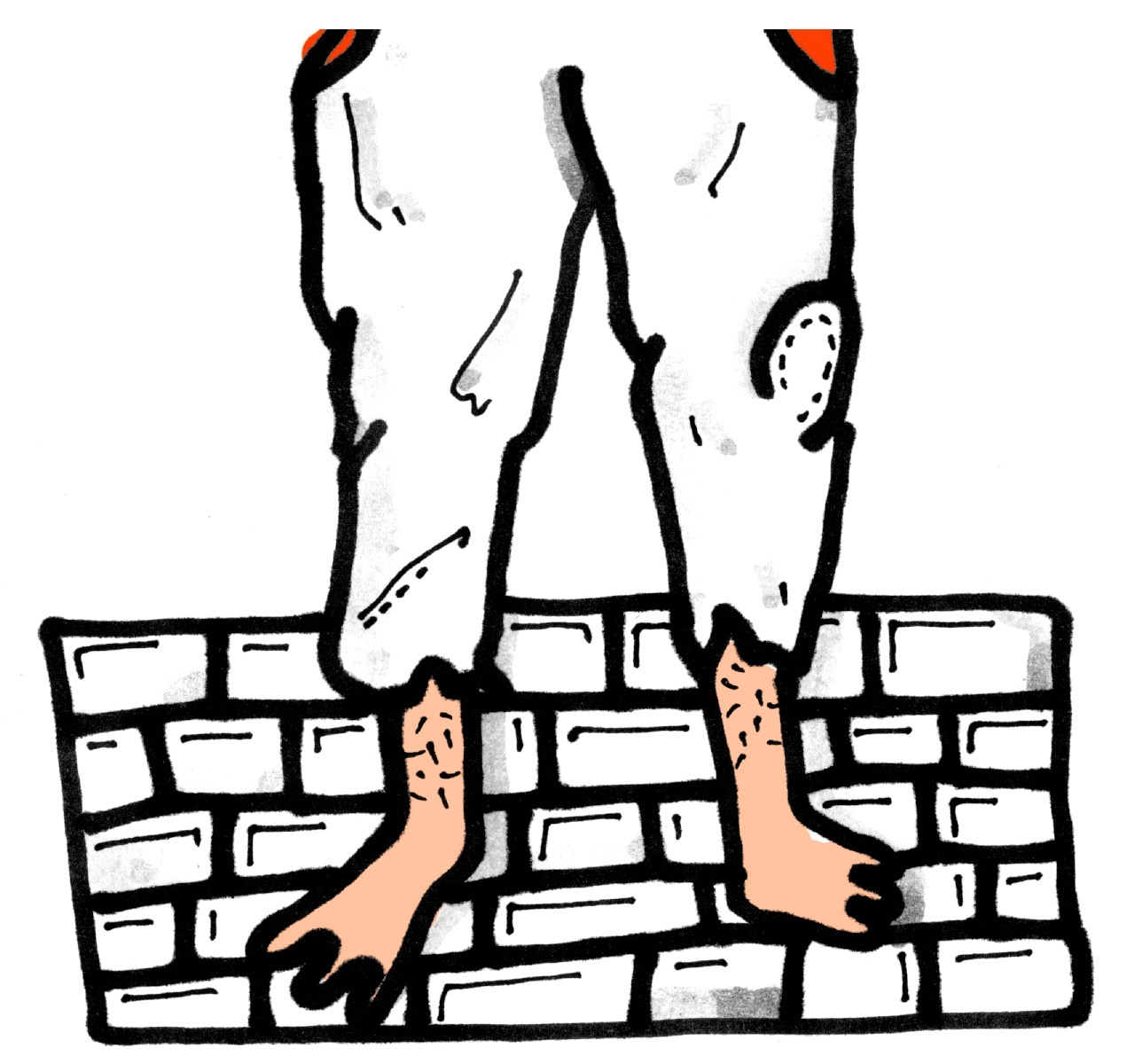
Nella notte tra il 20 e il 21 marzo, poco prima delle nove, fiamme altissime sono divampate nella piazzola due del sito di stoccaggio “provvisorio” di ecoballe e rifiuti tal quale che si estende per diversi ettari davanti all’inceneritore di Acerra. Alla fine il bilancio, su più di diciottomila tonnellate di rifiuti impilate nella piazzola due (solo una parte delle centomila accumulate ad Acerra), è di settemila tonnellate ridotte in cenere, che hanno liberato nell’aria un fumo nero e denso sparso dai venti sulle province di Napoli e Caserta. Il più grande rogo di rifiuti a memoria d’uomo in Campania, avvenuto in un’area dichiarata di “interesse strategico nazionale” e presidiata 24 ore su 24 da un contingente di militari del battaglione San Marco, nonché da volanti della polizia e da agenti di vigilanza privata. Stando a quanto emerge dai primi rilievi, l’incendio sarebbe di natura dolosa: due dispositivi a tempo sembra siano stati piazzati alla base delle piramidi in fori praticati nei teloni di copertura, con l’evidente scopo di generare due fronti di fiamma perpendicolari che distruggessero la totalità dei rifiuti in piazzola.
Ennesimo atto della crisi infinita, direbbe qualcuno. Personalmente, non utilizzo più le parole “emergenza” o “crisi” dei rifiuti, non hanno più alcun senso in tale contesto, schivano anzi la condizione sistemica di compromissione delle matrici ecologiche di cui stanno facendo esperienza i campani, a lungo termine e con effetti per ora incalcolabili. L’inquinamento in Campania (e la gestione dei rifiuti a esso connessa) è oggi uno dei dati immanenti con cui confrontarsi per qualsiasi progetto di sviluppo si voglia attuare. Non è straordinarietà, è la base da cui partire. Proprio per tale ragione, è necessario più che mai allargare lo sguardo dalle responsabilità istituzionali e criminali, per concentrarsi sui cambiamenti che sono avvenuti e stanno avvenendo nel panorama sociale ed economico circostante. Soffermarsi sulla mutazione culturale, sui cambiamenti dei rapporti di potere, delle capacità d’iniziativa e delle possibilità esistenziali, che una vera e propria involuzione ecologica sta imprimendo alle comunità più colpite.
Acerra, che è anche il mio paese, è da più di un decennio un punto d’osservazione privilegiato (o maledetto) per considerare il presente e il possibile futuro dei paesi della Campania. Il grande incendio di ecoballe è l’ultimo sfregio a una comunità che si sente condannata da altri a un destino mortifero. Quest’evento, che non ha ricevuto attenzione né dai media né dalle alte cariche politiche, esaspera se possibile la consapevolezza della mancanza di argini contro una distruzione che avanza perentoria. Il grande incendio si andrà a sommare, nella memoria collettiva degli abitanti, alle innumerevoli date “storiche” della cronologia della disfatta. Tanti e tali sono i momenti memorabili che ormai la maggioranza fa a meno di rubricarli e considerarli, costringendosi a sostituire alle minacce aleggianti nell’aria e nella terra la quotidianità stordita di periferia diventata frenetica. Solo un manipolo di cittadini continua l’opera di ricerca minuziosa, denuncia dei misfatti e presenza sui fronti ecologici aperti: sono i sopravvissuti alla lunga stagione di partecipazione spontanea e di massa avvenuta quando ancora si poteva intravedere una speranza di rivalsa, e che fu piegata definitivamente con la forza di polizia nelle campagne acerrane in un mattino di fine agosto del 2004. I nemici che gli ambientalisti affrontano, oggi come allora, sono sempre gli stessi: nemiche le istituzioni impegnate nei loro disegni tecnici legati alle necessità del momento, nemici i progetti di insediamenti industriali altamente inquinanti nelle campagne coltivate, nemici gli stessi concittadini quando colpevoli di scarsa sensibilità ambientale. Oggi come allora, la strategia che apparati politici e imprenditori dei rifiuti utilizzano per fiaccare le flebili voci di protesta rimaste, è la stessa: costringere alla rinuncia per estenuazione e per manifesta inferiorità di mezzi; in fondo, tutti hanno da pensare al pane da guadagnarsi e nessuno vive di sola militanza.
Il tema della “questione ambientale” ad Acerra è diventato però argomento politico. I partiti locali da destra a sinistra si affrettano a farne un punto chiave dei programmi per le prossime elezioni amministrative. L’inquinamento ha creato dei professionisti dell’ecologia, abili in una certa retorica capace di imbastire promesse che richiamino simboli e parole “ambientaliste”, smerciate come ami nell’elettorato più sprovveduto. Si fa man bassa dello sfacelo, per guadagnarsi magari un seggio in consiglio comunale. Le lotte intestine si accendono intorno agli argomenti ambientali, i candidati fanno la voce grossa per illustrare tutti gli errori o i meriti delle passate amministrazioni, con il risultato di riprodurre nella comunità le fazioni tipiche della dialettica politica italiana. Ingabbiati in una specie di sogno, o di delirio, che oscura invece di svelare la cogenza dei problemi ecologici. Acerra sconta un decennio di scarichi tossici della fabbrica chimica Montefibre, subisce gli effetti della più grande discarica abusiva di rifiuti industriali nel circondario, su cui la famiglia dei Pellini, acerrani purosangue, si è arricchita per anni; vive, infine, all’ombra delle alte torri dell’inceneritore e di nuovi impianti chimici che sorgono nell’area industriale in espansione. Le campagne coprono ancora la maggioranza del territorio comunale, ma chi mangerebbe friarelli e percoche cresciuti su fusti di liquami e annaffiati da acque di scolo? In un mondo che riscopre le produzioni locali contro le logiche dell’agrobusiness, Acerra con la sua tradizione agricola potrebbe puntare su coltivazioni biologiche e su un nuovo ruolo delle campagne. Non vi sono altre occasioni che uniscano larga occupazione, sostenibilità ambientale e qualità della vita. Ma la ferita dell’inquinamento si allarga su questo lembo di terra, ne strappa le potenzialità rigeneranti, ne decreta la prossima cementificazione totale. L’iniziativa del singolo che voglia intraprende un’impresa economica oggi si riduce a un già ipertrofico terziario di commercio e servizi, con il commercio strozzato da flessione dei consumi e competizione con le cittadelle-ipermercati. La patina di benessere rimasta si sta erodendo dovunque, ma quando anche ad Acerra non resterà abbastanza denaro per dimenticare dove si vive, gli abitanti si sveglieranno di schianto, scoprendo il deserto che lentamente hanno contribuito a spianarsi intorno.
È Acerra, ma potrebbe essere Giugliano, Casalnuovo, Pianura, Chiaiano,Terzigno, Sant’Arcangelo, o un altro dei Comuni campani che guadano il presente di melma e inquinamento con occhi accecati da fumi tossici e mani impegnate a strapparsi a vicenda i pochi fili d’erba rimasti. La condanna più grave è che la loro storia non esiste se non per loro. Il catalogo delle dichiarazioni politiche o i dossier sulle responsabilità di crimini ambientali, che oggi prendono tutto lo spazio della visibilità giornalistica, narrativa e cinematografica, dovrebbero essere invece un corollario al racconto di come la vita sta mutando nella Campania post-agricola. Si scoprirebbe che gli abitanti dei paesi assediati dall’inquinamento non sono rimasti a guardare. Riuniti in associazioni, comitati e gruppi di professionisti, hanno prodotto conoscenze ed esperienze di autorganizzazione, avanzato proposte ma anche attuato prese di responsabilità, simboliche e fattive, di porzioni del territorio, rivendicando che gli spazi pubblici non sono un’anomalia del privato, e che “comune” non vuol dire “di nessuno”. Scarsi, se non nulli, sono gli strumenti attraverso cui le comunità possono partecipare all’autogoverno dei propri territori, nonostante le convenzioni europee e le leggi in materia. E pure, dove la diplomazia non ha funzionato, sono stati posti come ultima difesa i corpi, che in verità sono il vero luogo dove la battaglia ecologica si combatte e si esaspera.
Questo movimento sociale di massa non ha avuto i suoi cronachisti, ancora. La mutazione in corso nella cultura come nella fisicità dei territori non è stata intercettata, sviscerata, e come il pessimismo quasi nichilista degli abitanti di una terra morente non s’è potuto cogliere nelle sue numerose implicazioni, così non è stato neppure ravvisato il nucleo di una nuova sensibilità emergente nei confronti dell’ecologia della vita. La spinta che arriva da pochi ma fermi nuovi contadini è ciò che di più moderno sta avvenendo in Campania, altro che forum e coppe. Un nuovo tipo di concezione della produzione e del consumo, un’attenzione ritrovata alla specificità locale come risorsa e alla convivenza pacifica con gli elementi basilari dell’esistenza, è un processo che in molti luoghi del mondo sta avvicinando le persone tra loro e ai loro territori. E nel sud dell’Italia, ancora agricolo e con una tradizione da cui attingere, le condizioni ci sono tutte. Ecco, questo non viene raccontato, e si finisce per dipingere i campani, oltre che con le stimmate degli infetti, anche con il silenzio colpevole degli ignavi. Solo chi vive qui sa che non è così, e bisogna raccontarlo. (salvatore de rosa)


Leave a Reply