
È di qualche settimana la notizia della sentenza di primo grado relativa al processo Montefibre, emessa dal giudice monocratico Daniela Critelli del Tribunale di Nola. I cinque ex dirigenti dello stabilimento chimico di Acerra Giovanni Elefante, Roberto Paolantoni, Gennaro Ferrentino, Luigi Patron, Giseppe Starace e due medici aziendali, accusati dell’omicidio colposo di ottantotto operai morti di tumore a causa dell’amianto tra gli anni Ottanta e Novanta, sono stati condannati per un unico caso di mesotelioma peritoneale riconosciuto, quello di un ex dipendente morto nel 2001. Gli imputati sono stati assolti con formula dubitativa dall’accusa di disastro colposo. Assolto per non aver commesso il fatto l’ex dirigente Raffaele Grieco. Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro novanta giorni. Nel 2000, le denunce dei parenti di trecentoventi operai della Montefibre morti per cancro avevano portato all’apertura di un’inchiesta, coordinata dal pubblico ministero della procura di Nola Giuseppe Cimmarota. Erano quattro le patologie da valutare: tumore ai polmoni, alla laringe, al fegato e mesotelioma pleurico (effetto, quest’ultimo, per la quasi totalità correlato all’esposizione alle fibre di amianto). Il processo iniziò sette anni dopo, ma in seguito alle varie perizie dei medici, i decessi presi in considerazione nel dibattimento riguardarono solo ottantatre dipendenti rispetto ai trecentoventi iniziali. Qualche settimana fa, la commissione scientifica nominata dal tribunale ha stabilito che sei operai sono certamente morti a causa della presenza di amianto nello stabilimento di Acerra; infine, per la condanna a un anno e otto mesi di reclusione nei riguardi di cinque ex direttori e due medici aziendali, il tribunale ha valutato la morte di un solo operaio, mentre agli altri deceduti non è stata riconosciuta una relazione tra la presenza di amianto in fabbrica e le cause dei decessi.
Lo stabilimento della Montefibre, leader mondiale nella produzione e vendita di fibra acrilica, è entrato in funzione ad Acerra nel 1978, in mezzo alle campagne. Una società di anonimi azionisti aveva designato la vastissima area di Contrada Pagliarone come luogo in cui insediare gli impianti chimici di produzione del poliestere. Ettari ed ettari di terra agricola acquistati e predisposti alla costruzione di nuove apparecchiature giganti provenienti dal Giappone e dalla Germania avrebbero trasformato per sempre l’equilibrio ambientale, sociale ed economico del territorio circostante. Ci sarebbe stato lavoro salariato per migliaia di uomini, molti dei quali provenienti dallo stabilimento Rhodiatoce di Casoria, dal rione Baronessa di Barra, da Acerra, Afragola, San Giovanni a Teduccio, Casavatore, Caivano, dall’hinterland napoletano. Uomini che grazie a quel posto sarebbero diventati padri di famiglie più o meno numerose, che vedevano in quell’industria una reale prospettiva di emancipazione. Quella fabbrica avrebbe nutrito i loro figli, avrebbe riservato per loro l’accesso a uno status sociale diverso da quello dei padri, gli avrebbe permesso di andare all’università, magari di studiare. Era arrivato il benessere sotto forma di pane e poliestere, e il prezzo da pagare a quei tempi ancora non era visibile (l’attenzione era tutta rivolta verso il pane). La devastazione odierna, la distruzione delle terre, l’avvelenamento, i morti per tumore, l’inquinamento irreversibile sembrano lontani anni luce dalla fine degli anni Settanta (anche se un decreto ministeriale dell’87 definiva Acerra come un territorio ad alto rischio ambientale, con elevati tassi d’inquinamento). A quei tempi l’immagine della catastrofe ambientale non era ancora sotto gli occhi di tutti. Allora prevaleva l’illusione dell’agiatezza, il televisore, l’automobile, la villeggiatura, la casa in montagna, in definitiva la speranza di potersi liberare una volta per tutte dalla miseria, dalla fame, dalla disoccupazione. Bisognava crederci e basta. Nel giro di vent’anni molti contadini diventarono operai, nacquero nuovi bisogni superflui insieme al miglioramento della qualità della vita. L’insediamento della Montefibre ad Acerra rappresentò una rivoluzione drammatica e sublime. Nulla sarebbe stato più come prima.
La superficie dello stabilimento era talmente vasta che per andare da un reparto all’altro gli operai prendevano un pullman. Il processo di produzione era determinato inizialmente dal reparto centrale che alimentava tutti gli altri impianti. Allora esisteva solo il reparto di fusione filo, e le materie prime provenivano dalla Germania con delle cisterne guidate da camionisti che riempivano di birre tedesche gli operai. Solo negli anni Ottanta furono avviati il reparto DMT (che produceva il dimetiltereftalato) e il reparto di polimerizzazione, finalizzati alla produzione dei polimeri. Tra i due reparti c’era il laboratorio chimico, in cui avevano luogo le analisi del prodotto nella sua fase intermedia (ci torneremo in seguito). Dall’inizio degli anni Ottanta lo stabilimento era finalmente in grado di produrre la materia prima capace di realizzare i prodotti finiti, vale a dire i fiocchi (come quel materiale all’interno dei cuscini) e i fili avvolti in bobine (come i fili di cotone).
Il primo processo nel reparto DMT produceva una reazione simile a quella della bomba atomica. L’impianto, avviato nell’82, faceva paura a tutti. Se fosse scoppiato i suoi pezzi sarebbero arrivati fino a Caserta. Ma a parte un incendio a una pompa di metanolo, non si registrano incidenti gravissimi. I reattori a reazione esotermica intimorivano anche i vigili del fuoco di Afragola, che quando entravano nei dettagli del processo di produzione ponevano sempre la stessa domanda al capoturno che partecipò all’avviamento di quell’impianto, in servizio per venticinque anni sotto a quel reparto: «Ma non avete paura?». C’erano tre reattori e otto fasi di lavorazione continue prima che il dimetiltereftalato diventasse materia da poter alimentare il processo di polimerizzazione. Tra le altre sostanze utilizzate, il paraxinolo, il metanolo, l’etilenglicole, l’acetato di cobalto, l’acetato di manganese, l’acetato di metile, l’acido acetico. Tutte sostanze dannose, nocive, cancerogene e soggette a particolari regolamentazioni. Il DMT prodotto nel primo reparto, aggiunto al glicole, veniva utilizzato come materia prima nell’impianto di polimerizzazione. Da lì usciva il polimero, e dopo le analisi effettuate nel laboratorio chimico il prodotto entrava attraverso le linee in due reparti paralleli, il reparto fusione fiocco e il reparto fusione filo. Tra questi due impianti c’era il laboratorio tessile, il luogo “più salubre” dello stabilimento, e allo stesso tempo il più faticoso. Il fiocco e il filo si vendevano come prodotto finito.
L’amianto era presente ovunque, isolava le linee in cui passavano le sostanze chimiche. Per esempio, al reparto DMT il prodotto aveva un punto di ebollizione che al di sotto di centocinquanta gradi diventava pietra, non era più liquido. Per questa ragione doveva camminare in linee coibentate con l’amianto e la lana vetro. La tossicità delle sostanze trattate negli impianti era ancora più evidente nella misura in cui non circolavano soltanto nelle linee e nelle pompe. Queste sostanze infatti evaporavano, avvenivano di continuo fuoriuscite di metanolo, che nella fase gassosa sarebbe dovuto entrare in un recipiente, il gasometro, in modo tale da non farlo disperdere nell’ambiente. Solo che questo gasometro non ha mai funzionato. I reparti maggiormente sovraesposti alle sostanze tossiche erano il DMT, il laboratorio chimico e il reparto di polimerizzazione. Nel laboratorio chimico morirono più di dieci operai nel giro di una quindicina d’anni, uno dopo l’altro, all’improvviso, a causa delle inalazioni e del contatto con le sostanze utilizzate per analizzare i prodotti. Qualche anno fa è morto anche Fernando, il capo del laboratorio. Un piccolo impianto pilota realizzava le analisi al polimero che usciva dall’impianto di polimerizzazione, e veniva utilizzato un prodotto cancerogeno, l’ortoclorofenolo, il cui fetore s’impregnava nei panni e restava appiccicato addosso per una settimana. In quegli anni ad Acerra lavoravano circa duemila operai.
Ma era l’ambiente a risultare totalmente inquinato all’interno dello stabilimento. Ai lavoratori, sia nei turni notturni che diurni, insieme al sacchetto del pranzo e della cena distribuivano sempre le buste di latte. Oltre ai livelli a sonda radioattiva (l’azienda ha sempre detto che erano talmente bassi che ne prendevi molte di più con una radiografia) c’era la questione del trattamento delle acque. L’ex dirigente di allora fu condannato per questa vicenda. Prima di buttarla nel Consortile, (l’ente che avrebbe dovuto controllare la qualità dell’acqua, per poi mandarla ai depuratori regionali) l’acqua era trattata all’interno della fabbrica, ma l’azienda non riusciva a farla rientrare in una fascia accettabile e le lamentele erano all’ordine del giorno. Nell’acqua venivano alimentati dei microrganismi che morivano. Il direttore di allora creò una vasca di stoccaggio immensa, di circa cinquanta metri per cinquanta, proprio nei pressi dell’impianto DMT. Prima di portarla al trattamento, l’acqua veniva stoccata in questa vasca, e da allora il fetore in quel reparto divenne insopportabile. Lì dentro si accumulava l’acqua di scarico utilizzata dai vari reparti per i lavaggi chimici. Nello stabilimento esisteva un impianto di depurazione delle acque, ma non funzionava. Il trattamento consisteva nel buttarci dentro la calce viva, utile a correggere il ph, vale a dire l’acidità. Dopodiché veniva portata al Consortile, ma era impossibile smaltirla totalmente. Varie volte i lavoratori del reparto DMT minacciarono di denunciare il fatto ai Nas, per via della puzza insopportabile proveniente dalla vasca. Uno di questi operai fu chiamato nell’ufficio del direttore che gli disse: «Tu puoi fare tutti i passaggi che vuoi, alla fine succede che ti chiudono la fabbrica… Poi te la prendi tu la responsabilità di non far entrare tutta la gente qua dentro?». L’azienda poneva l’operaio davanti a responsabilità più grosse di lui, e tutto sommato non era difficile corrompere i vigili sanitari.
I contatti che gli operai erano costretti ad avere con le sostanze chimiche nella fase di manutenzione dell’impianto DMT nel periodo di luglio, agosto e settembre erano ravvicinati, costanti. In quei tre mesi, tutte le apparecchiature si svuotavano a terra, non si capiva più niente, saltavano tutti gli schemi riportati su tabelle, fogli e carte che poi diventavano documenti e faldoni lontani dalla realtà quotidiana dello stabilimento. Per affrontare questa situazione perennemente precaria, l’azienda creò il responsabile di ambiente e sicurezza, una struttura che comandava i vigili del fuoco e curava la preparazione del personale all’esposizione nei vari reparti. L’operaio veniva istruito sui rischi. Era una strategia adottata dall’azienda per tutelarsi. Il colosso chimico, una volta creato un ufficio di ambiente e sicurezza, produceva tutta una serie di documenti che attestavano su carta le spese e gli investimenti sulla prevenzione, la sicurezza e la realizzazione dei corsi di formazione. Nonostante l’evidenza, l’azienda avrebbe potuto dimostrare il contrario attraverso quella documentazione, ma la verità non era scritta in quelle scartoffie. Le responsabilità in tal modo sarebbero ricadute sui lavoratori. Sulla carta tutto era chiaro, limpido, regolare. Nei fatti non c’era niente che corrispondesse a quei documenti. Sta accadendo lo stesso all’Ilva di Taranto in questi giorni.
C’era un altro problema gravissimo: quello dei fusti che contenevano gli scarti di lavorazione, prodotti in quantità enormi dall’impianto di polimerizzazione. Si trattava di scarti chimici sorti con l’avvio del reparto, che versati prima in un serbatoio alimentavano inizialmente una colonna, essendo ancora presenti residui di prodotto utilizzabile. Poi venivano distillati a varie temperature e pressioni. Quando infine si estraevano questi scarti, rimaneva una sostanza melmosa che in un primo momento avrebbe dovuto alimentare dei forni, ma questa melma intasava l’impianto e i residui non si riuscivano a bruciare. Scelsero quindi di smaltirli all’esterno della fabbrica. Ogni giorno dallo stabilimento partivano tre, quattro camion carichi di quei bidoni, e a parte gli ex dirigenti della Montefibre, nessuno sa dove li portarono in tutti quegli anni. Quando venivano interrogati sulla questione ripetevano sempre la storia dei permessi in regola e dei malloppi di documenti che dimostravano il regolare smaltimento in discariche autorizzate. Tuttavia lo smaltimento era gestito da una ditta che faceva riferimento a un boss di Casal di principe, che entrò in Montefibre con un’impresa di pulizie e diventò in poco tempo il padrone di mezzo stabilimento. Con il passare degli anni risultò impossibile smaltire tutti quegli scarti chimici, che intanto si accumularono all’interno della fabbrica, in una zona destinata al deposito dei fusti. Era la metà degli anni Ottanta, gli operai, e con loro i pastori acerrani, iniziarono a lamentarsi di quei bidoni parcheggiati nel terreno. Quando pioveva tracimavano, con il caldo emanavano un fetore nauseabondo e mortifero. L’azienda fece costruire un’enorme pedana di cemento su cui appoggiarli, si formarono tre, quattro livelli di fusti che furono ricoperti con un tendone, e da allora sono rimasti là dentro. Gli scarti di lavorazione sono stati prodotti fino alla chiusura dell’impianto di polimerizzazione e dell’intero stabilimento, nel 2004, determinata dalla decadenza del monopolio del brevetto e dalla concorrenza asiatica. Dalle parti di Taiwan cominciarono a realizzare degli impianti simili che producevano gli stessi polimeri a metà prezzo.
Il tribunale di Nola ha ammesso la presenza di amianto, eppure tutti sanno che la Montefibre di Acerra è stata una fabbrica di veleni in cui l’amianto non è che uno tra i tanti prodotti nocivi con i quali gli operai hanno avuto a che fare. Tutti (soprattutto gli ex dirigenti) sono a conoscenza del modo in cui venivano smaltiti gli scarti di lavorazione, tutti sapevano del trattamento delle acque di scarico, della sostanza cancerogena utilizzata nel laboratorio chimico. In un appartamento nei pressi di Caivano ho conosciuto alcuni dei familiari coinvolti nel processo. Carmelina, vedova di Francesco Tozzi, portava il fotoritratto rimpicciolito di suo marito al collo; erano presenti Pino e sua madre Giovanna, vedova di Antonio Esposito; Gennaro, operaio in pensione. Ancora non riescono a comprendere il senso della sentenza, e dopo anni di battaglie, continuano ad attendere che sia fatta giustizia. “Nulla di più terribile che aver ragione”, ammoniva il filosofo tedesco Gunther Anders. Ma a quelli che, paralizzati dalla fosca probabilità della catastrofe, si perdono di coraggio, non resta che perseguire, per amore degli uomini, la massima cinica: “Se siamo disperati, che ce ne importa? Continuiamo come se non lo fossimo!” (andrea bottalico).



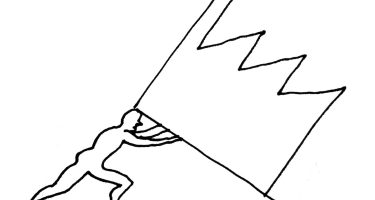

Leave a Reply