
Le scuole pullulano di discorsi, fondi e iniziative contro la dispersione scolastica. Centinaia di docenti e decine di dirigenti presidiano il fronte delle scuole di confine. Qualcosa si muove, qualche speranza di recuperare brandelli di esperienze sperimentali si affaccia all’orizzonte. I dispositivi avrebbero grandi potenzialità. Obiettivo dichiarato è l’innovazione del sistema scuola; premessa e promessa è che i risultati devono essere visibili, pubblici e verificabili; che insieme alle configurazioni didattiche, pedagogiche e organizzative si modifichi anche la competenza e il mansionario della professione docente.
Dalla spesa si passa all’investimento, cioè alla prospettiva che qualcosa si capitalizzi in termini di innovazione cognitiva e organizzativa, in modo da “mettere a sistema” qualcosa di nuovo e così drenare i fondi straordinari verso atri lidi. Prospettiva interessante e a sua volta innovativa. Ma chi naviga si muove nelle terre di mezzo tra i discorsi e le pratiche e avverte che la vita vera, il clima delle scuole non è tanto vicino alle retoriche e ai dispositivi.
Quand’ero ragazzo, anzi bambino, nel vicolo dove vivevo sentivo spesso gli adulti dire, per giustificare i ragazzi che avevano fatto qualcosa di male, “quello è stato per mezzo degli altri”. Nessuno era mai responsabile, c’era sempre qualcuno che aveva negativamente influenzato i comportamenti del ragazzo, rendendolo vittima e non autore di qualunque malefatta: “per mezzo”, in questo caso, univa i complementi di causa e di strumento. Gli adulti educanti, in particolare, si auto-assolvevano con l’espulsione da sé d’ogni responsabilità attribuendola ad altri.
Lo scarico paranoico della colpa ne ha fatta di strada. Per mezzo degli altrialtro non è se non il capro espiatorio, l’invenzione di qualcuno o qualcosa a cui viene fatta assumere, espellendola da sé, tutta la responsabilità, la colpa, la causa del male. È una proiezione che serve alla purificazione, sentirsi innocenti a differenza del capro.
Sono andato poco tempo fa a un incontro organizzato dall’assessorato all’istruzione del comune di Napoli sulla scuola. A parte il sempiterno discorso sulla dispersione, sempiterno perché tenuto in vita da sempiterne parole d’ordine e sempiterne chiavi di lettura, una parte dell’incontro era dedicato ai rifiuti o qualcosa del genere. Davanti a docenti, pochi, che si impegnano per evitare che la scuola produca rifiuti, Del Giudice, presidente di Asia, parlava del ciclo alimenti (perché s’era parlato anche di mense scolastiche) e rifiuti. Io a Del Giudice voglio bene e lo feci venire anche a scuola mia, un paio d’anni fa, perché mi sembrava uno dei pochi esperti, capace, tra l’altro, di infiammare l’anima dei ragazzi, anche di molti di quelli rifiutati. Allora andò bene, una fiammata di emozione civile ci travolse (dico sul serio), ma poi le abitudini ripresero il sopravvento.
Torniamo a noi.
Del Giudice, questa volta, non mi ha fatto lo stesso effetto, nonostante io provassi lo stesso affetto. La sua tesi è che i rifiuti sono un problema perché i napoletani sono incivili. Questa originale tesi era condita da un repertorio di aneddoti vicini alle barzellette, in stile berlusca, così che l’attenzione si appuntava sulle battute e non sull’argomentazione, ove mai ci fosse. Tutti ridevano e si guardavano compiaciuti: siamo della stessa parrocchia, siamo quelli bravi, non siamo né la camorra né la plebe. È “per mezza loro”, insomma, dei napoletani, diceva Del Giudice, che non si fa la riciclata. I napoletani sono i caproni, le istituzioni e i suoi amministratori sono innocenti.
Detto ciò davanti a una mezza dozzina di docenti e di uomini e donne istituzionali che combattono affinché la scuola non produca rifiuti, ragazzi espulsi, la cosa avrebbe dovuto scandalizzare: e cosa direste, immaginavo qualcuno dicesse, se noi impegnati contro evasione, disagio, espulsione, vi dicessimo che quella la scuola non funziona “per mezza loro”, “per mezza” dei ragazzi che non sono buoni? Nessuno, neanche io, sconfitto dai legami vaghi e antichi di amicizia che spesso diventano irretita complicità, ha obiettato nulla a Del Giudice e alla singolare, per un amministratore, tesi per cui la colpa è degli amministrati.
Il fatto è che sempre più spesso “per mezza loro, per mezzo degli altri” sta diventando la chiave interpretativa dei fenomeni negativi che la città non riesce più a contenere. Cioè, istituzioni e uomini, e donne, pagati per fare politica, dare risposta ai problemi, chiamati in quanto esperti, analizzano il problema che dovrebbero risolvere e poi l’epistemologia del “per mezza loro, per mezza degli altri” trova la risposta: dopo tutto quello che facciamo per te, tu così ci ripaghi, sei tu che non sei buono, vai via. Noi te l’abbiamo pure spiegato, ma tu non stai attento.
E fin quando il “per mezzo degli altri” riguardasse solo gli altri, cioè gli esperti, tanto quanto. Ma il fatto è che prima d’essere una teoria è un “sentimento” diffuso anche nelle comunità di lavoro, tra docenti ed educatori, per esempio. Educati inconsapevolmente all’onnipotenza, educati da formatori supereroi, formati in una cultura della prestazione e del successo, drogati da fondi e fondi, di fronte a ciò che è vissuto come un fallimento e non come un debole e umano tentativo di cercare risposte e soluzioni, non possono sostenere la loro immagine dequalificata e tutto ciò è incontenibile.
La scuola, per esempio.
L’associazione con cui in questo momento collaboro fa una meritoria opera di genitorialità sociale. Accompagna – tra l’altro – ragazzi a iscriversi a scuola. Supplisce così alla debolezza delle informazioni, alla debolezza delle famiglie, garantisce un diritto anche a chi non sa di averne. Eppure, questa funzione, che magari in silenzio è stata accettata o subita, ora dalla scuola viene sempre più spesso rifiutata: l’associazione è ritenuta responsabile di portare problemi, o è considerata spesso alla stregua di un informatore: il suo ruolo dovrebbe essere quello di dire quali siano i problemi dei ragazzi problematici, per imprimere loro uno stigma, per coinvolgere la scuola nel loro controllo, se non negli allontanamenti. Cittadini giovani che accompagniamo a compiere un dovere e un diritto, iscriversi per completare l’obbligo, diventano per le scuole i “nostri” ragazzi, senza più un nome proprio, diventano i ragazzi dei servizi sociali, ai quali siamo associati, laddove nessuno si perita di capire o informarsi che associazione e servizi son cose differenti: a loro importa pensare che sono la stessa cosa, perché portano le mele marce a scuola e poi li abbandonano. L’abbandono, quasi quasi, è per mezza nostra. È diffusa la pratica per cui il farsi carico, ruolo che le associazioni hanno scelto di svolgere, diventa un “levateceli di torno” fino agli esami. L’umore silenzioso trova ormai anche la voce, spesso istituzionalmente qualificata, che esprime il fastidio e il rifiuto di chi – una specie di maggioranza silenziosa – per anni ha dovuto subire l’invasione e restare zitto.
In un’altra scuola, gentile nell’ascoltare le richieste fin quando magari si trattava di formare gli organici e i ragazzi erano ancora solo dei numeri, e come tali utili, prima di diventare problemi, all’improvviso si serrano le porte dell’accoglienza: non si viene neanche ricevuti. Questi ragazzi, gli scappa a qualcuno, sono mele marce (e come tali rovinano anche le altre). Insomma, in maniera occulta e magari inconsapevole, si rimarca la linea, la frontiera, tra la città civile e quella incivile.
La retorica e i fondi per la lotta all’esclusione farebbero immaginare sentimenti positivi e, perché no, un po’ di allegria nell’intraprendere un’impresa civile. E invece, evitate le voci superomistiche e i trionfalismi, se uno fa un capannello, un caffè, quattro chiacchiere o anche origlia, sente uscire, dalla bocca di dirigenti capofila e di docenti, spesso anche di quelli “coinvolti”, che ci sono le mele marce, che i ragazzi portano problemi, che stanno coi servizi sociali, che se stanno con le associazioni vuol dire che non sono buoni. Se guarda le pratiche, scopre che ai sorrisi dell’accoglienza indiscriminata – serviva a fare gli organici? – subentra, quanto prima possibile, l’espulsione: l’immagine della scuola va difesa. Il suo target anche: se questi ragazzi non hanno vocazione, non sono stati orientati, che ci vengono a fare? Le porte sempre aperte si chiudono, i sorrisi si spengono. Il circuito vizioso tra la retorica e la disponibilità necessarie per accedere ai finanziamenti, la torta da dividere, come qualche dirigente ha detto, si chiude intorno alle pratiche di minuscoli e locali poteri.
Il fatto è che talvolta le scuole dimenticano la loro missione e diventano sistemi autocentrati, in cui i fondi per il successo scolastico vengono utilizzati quanto più è possibile all’interno dell’istituzione, con alchimie distributive, come se fossero soprattutto integrazioni stipendiali (un ammortizzatore sociale che indebolisce la forza della potenziale e giusta protesta per condizioni di vita e stipendiali davvero misere). Progetti nati – come gli ultimi per i prototipi contro la dispersione scolastica – sul presupposto della necessità di aprire ai saperi delle associazioni che lavorano sul territorio, sull’enfatizzazione delle figure tutoriali come accompagnamento alla crescita e all’apprendimento, vengono stravolti in una logica distributiva delle risorse, in meccanismi che rinforzano la centralità autoreferenziale della scuola e mortificano i saperi sociali: il signore feudale offre benefici in cambio di vassallaggio, il potere resta assoluto. Spesso le scuole si sentono come banche private, coi loro fondi, quando invece sono fondi europei, da distribuire ai vassalli. Una sorta di ritorno al feudalesimo, dove l’autonomia diventa autoreferenzialità e il pubblico privatismo.
Di fronte al dilagare dell’esperienza dell’incapacità e dell’inefficacia, sarebbe semplice, per sentirsi innocenti e salvarsi, dire che questo fallimento istituzionale è colpa degli altri, degli operatori incapaci. È per mezza loro che i miei sforzi falliscono, che le mie verità non si affermano, che il mio esempio è rifiutato. È facile che di fronte agli altri emerga la figura illusoria e narcisista dell’adulto eroico, che l’iper-dedizione, il farsi carico, diventi un’ineffabile alternativa alla stanchezza e alla disillusione.
La domanda da porci, invece, scartata la facile soluzione del capro espiatorio, è un’altra: cosa ci insegna questa rappresentazione dell’impotenza, questa resa delle armi? Cosa ha di vero il ritorno di queste rappresentazioni reazionarie sulla gioventù incivile? Non è che ci aiutano a capire come è fatta la realtà su cui vogliamo intervenire? Non è più veritiera dei proclami del progressismo e del finto altruismo? Non è più istruttivo per noi, per capire i limiti delle nostre ideologie, un reazionario? Non capiamo di più se riflettiamo su cosa significa chiamare i ragazzi mele marce? Dov’è il marcio? Per mezzo degli altri è in realtà la foto spietata dell’arido vero della stanchezza e dell’impotenza, è l’ultima speranza di chi non vuole, giustamente, sentirsi colpevole perché le cose non cambiano. Diventare reazionari è allora la forma di un’illusione di salvezza, di un ritorno a un mondo che non c’è mai stato, quello dei ragazzini educati col grembiulino, è una denuncia dei limiti del progressismo standardizzato.
Chi parla di mele marce sta parlando, in realtà, della propria sofferenza. Questa sofferenza ci insegna qualcosa. Probabilmente dovrebbe farci sospettare che la nostra cultura, le nostre innovazioni, i nostri schemi del mondo hanno raggiunto il loro limite, sono diventati impotenti. Si possono riportare gli e-vasi nel vaso scolastico? O forse alla lotta contro l’evasione bisognerebbe sostituire una lotta per favorire l’evasione, per abbandonare un’istituzione che ha fatto il suo tempo, per provare a crearne davvero di nuove?
Il problema dell’evasione scolastica è diventato intrattabile secondo gli schemi dell’inclusione scolastica; ogni dispositivo è il paradossale faro su chi continua a rimanere fuori. E chi parla di mele marce forse ci sta dicendo di guardare il re nudo, di osservare spietatamente un meccanismo che oltre il maquillage non ce la fa più, neanche se aumentiamo le risorse. E che gran parte dei successi che si ottengono si ottengono laddove la scuola si è tanto modificata nei suoi assetti da non esser più una scuola. (salvatore pirozzi)


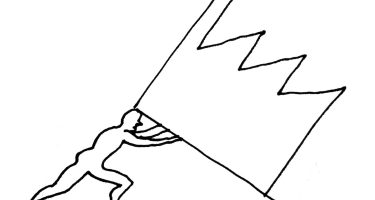


Leave a Reply