
da: horatio post
Per favore, visitatelo una volta il Parco dei Camaldoli, una mattina o un pomeriggio, e portateci i bambini. È il parco più strabiliante che abbiamo in città, il meno conosciuto. Lasci la macchina all’ingresso dei Camaldolilli e ti inoltri, in pochi minuti un miracolo avviene, la città scompare, ti avvolge il verde e l’odore silenzioso del bosco. Improvvisamente è come trovarsi in appennino, in quel grande castagneto che si estende per un centinaio di ettari – poco meno di Capodimonte – dalla sommità della collina, giù per i versanti e i valloni freschi, densi d’ombra e mistero.
Il Parco dei Camaldoli è la natura in città, ma anche la storia, perché il bosco ceduo di castagno è allevato così da un paio di millenni, e ha fornito fino alla metà del Novecento e all’affermazione del cemento armato, i pali per l’edilizia e le protezioni agricole. Questi boschi erano floridi e curati come un salotto, venivano ceduati ogni decennio, sulla base di una meticolosa rotazione. In questo modo il bosco si teneva leggero sul versante, esercitando al meglio la sua funzione protettiva, contro erosioni e frane. Un sistema di gestione estremamente razionale, iniziato coi romani o forse prima, e dobbiamo allora pensare a questi ecosistemi come a un centro storico verde, fatto di rami e foglie anziché di mattoni.
La storia del Parco è singolare, perché è stato realizzato negli anni Ottanta, con uno scampolo di fondi per il disinquinamento del golfo di Napoli: fu un valoroso funzionario comunale, Giovanni Dispoto – uno degli urbanisti poi frettolosamente e anzitempo congedati – a suggerire all’amministrazione (l’assessore era Giulio Di Donato) di usare i soldi rimasti per acquisire al patrimonio pubblico quel pezzo intatto di castagneto, salvandolo dalla speculazione, e facendone un parco pubblico.
Certo, non vi aspettate l’ordine dei Giardini Reali del Settecento. Qui c’è la selva, con la sua architettura ariostesca, l’intrico dei fusti, le antiche ceppaie che sembrano sculture, il ricamo verde del brachipodio e del pungitopo, le fioriture stagionali di pervinche, ginestre, ciclamini e rare orchidee.
Per tutte queste cose, allora, visitatelo una volta il Parco dei Camaldoli, perché l’antico bosco millenario sta morendo. In assenza di gestione, le ceppaie si affollano e deperiscono, l’una dopo l’altra. I fusti non ceduati muoiono e cadono, avvinti dall’edera, l’erosione inizia il suo lavoro, e l’atmosfera è quella suggestiva e tremenda di un bosco tropicale, con la vita che nasce dalla morte e dalla dissoluzione.
Lo spettacolo è grandioso, perché qui nulla finisce ma tutto si trasforma, e allora questo bosco ci parla del resto della città, che in fondo, anche nella sua parte costruita, quella che abitiamo tutti i giorni, è lasciata, in mancanza di cura, alla mercé delle stesse dinamiche dissolutive. Quello che questo bosco racconta, è che comunque la natura non sta ferma, nel centro storico di pietra come in quello vegetale; che la nostra inazione non comporta immobilità, ma comunque dinamica ed evoluzione, che lo vogliamo oppure no. In assenza di governo e manutenzione, Napoli diventa un grande esperimento ecologico e sociale, del quale noi abbiamo scelto di subire, inerti, le inesorabili risultanze.
Per questo, alla fine, quello che questo bosco ci dice – visitatelo per favore – è che prima di piantare alberi e realizzare nuove aree verdi, sarebbe bene ricordarsi di curare quelle che già ci sono (più di tremila ettari tra campagne, selve ed aree ricreative, come meticolosamente contabilizzato nel Piano regolatore del 2004). Partendo magari dal Parco dei Camaldoli, che in silenzio vive il suo struggente declino, e che continua, nonostante tutto, a raccontare alcune cose importanti su di noi. (antonio di gennaro)


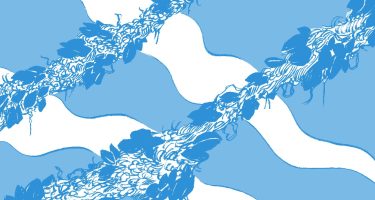


Leave a Reply