
da: Horatio post
Iniziarono gli Angioini a modellare le colline, da Poggioreale ad Agnano, perché la città cresceva, occupando tutti gli spazi di pianura, e gli agricoltori dovettero risalire i versanti, tagliare il bosco, e costruire i ciglioni e i terrazzamenti, trasferendo qui in alto gli schemi del “giardino mediterraneo”, con le viti e gli ulivi, arrivati duemila anni prima coi coloni greci. Poi il lavoro continuò nei secoli successivi, come racconta l’iconografia: dalla Tavola Strozzi di fine Quattrocento, ai paesaggi di Lusieri dipinti tre secoli dopo, fino alle foto di metà Novecento, quando le colline napoletane brulicavano ancora di vita e di masserie, con gli orti arborati curati come un salotto, prima che le mani si allungassero sulla città. La costruzione di questi paesaggi è stato un processo di lunga durata, e le sistemazioni collinari eroiche, che miracolosamente ancora interrompono la continuità caotica dell’edificato, sono il più grande monumento di civiltà medioevale che la città possiede, proprio come Santa Chiara.
Resta il problema di chi debba prendersi cura di questo museo vivente, all’aperto, visto che gli agricoltori urbani sono una specie in via di estinzione, e le aziende agricole nel territorio cittadino sono passate dalle circa tremila del 1980, alle poco più di cinquecento, che ancora oggi resistono.
È per incontrare uno degli eroi superstiti che sono venuto ad Agnano, con la luce che è cambiata, i colori e la foschia dorata sono quelli d’autunno. L’appuntamento è alla rotonda, Raffaele arriva cavalcando il suo quad, in t-shirt, scarponi, e i capelli neri che svolazzano dal cappellino: lascio la macchina e monto in sella anch’io, prendiamo una campestre nascosta che passa sotto i piloni della tangenziale, si inerpica in alto sul versante degli Astroni, in un attimo le automobili e i clacson non ci sono più, siamo in piena campagna, in mezzo agli antichi ciglionamenti angioini.
Qui Raffaele Moccia conduce l’azienda di famiglia, all’inizio erano quattro ettari di vigneto, con le viti secolari ereditate dal bisnonno, piante nodose bicentenarie, opere d’arte viventi, piante di piedirosso, falanghina, catalanesca, caprettone, gesummina, tutte “franche di piede”, perché questo è uno dei pochi posti al mondo dove la fillossera di metà Ottocento non arrivò, i suoli vulcanici sabbiosi e acidi sono sfavorevoli alla vita dell’afide che distrugge le radici, e perciò questi sono tra i rari vigneti non innestati su vite americana, resistente all’insetto, scampoli superstiti del vigneto europeo spazzato via dal parassita un secolo e mezzo fa.
Ho portato a Raffaele il mio libro sui suoli della Campania, ma stamattina è lui che dà lezione a me: profittando di un taglio stradale mi mostra la stratigrafia del suolo, leggendola e interpretandola come le pagine di un volume studiato con passione, con gli strati buoni, quello che lui chiama ’a rena ‘e fuoco, la sabbia di fuoco, un orizzonte profondo più scuro, di piccoli lapilli come acini di pepe, estremamente fertile, dove la pianta radica e si espande; e quelli cattivi, come il “tasso”, uno strato bianco, compatto, di ceneri fini come talco, impervio all’acqua e alle radici. Su questi suoli fragili, perennemente assetati d’acqua, mi spiega Lello, ci vuole tempo per costruire la pianta, per darle equilibrio, occorrono dieci anni perché un vigneto di piedirosso entri in produzione, e a ogni modo lo sviluppo vegetativo, come il carico di grappoli, devono essere costantemente tenuti a freno, affinché la pianta non si sfianchi in questo ambiente difficile. In questo modo, se raccogli quaranta quintali per ettaro è già tanto, anche se il disciplinare di produzione ne consentirebbe fino a cento.
Ma la passione di Raffaele sono le sue viti centenarie. Altrove questi antichi testimoni, dai fusti squamosi, involuti come arabeschi, che hanno visto la caduta dei Borboni e l’arrivo di Garibaldi, sono stati spiantati, per far posto al vigneto moderno, la cui geometrica razionalità facilita e sveltisce tutte le operazioni colturali. Al contrario, Raffaele ha incentrato il suo progetto aziendale sull’eredità degli avi, nella convinzione che proprio dal vigneto storico, potesse scaturire una qualità ancora sconosciuta.
Così ha ripreso le antiche piante che si erano schiantate, le ha tirate su, ha rifatto i sostegni, le ha potate con garbo, senza stravolgere la struttura, rispettando le forme d’allevamento e i vecchi sesti di impianto, irregolari perché rispondenti ai mutamenti minuti della topografia, coi diversi vitigni che formano un mosaico anarchico, e ciò significa che per potare e raccogliere devi conoscere il vigneto pianta a pianta, come una vecchia foto di famiglia.
Poi è passato oltre. Quando si è accorto che nei poderi vicini il vigneto storico veniva spiantato, terrazza dopo terrazza, proprio come l’allevatore bisbetico nel film Seabisquit, che salva il campione azzoppato («Non si prende una vita e la si butta via solo perché ha qualche difettuccio») ha parlato con i conduttori, li ha convinti a desistere, spiegandogli che sradicare una vite centenaria è un delitto, convincendoli ad affidargli gli antichi filari. In questo modo Raffaele ha ampliato l’azienda, ora sono circa dieci ettari, ed è il vigneto storico più importante della città.
Intanto il quad prosegue l’arrampicata tra i terrazzi, la cosa si fa avventurosa, sui sentieri sempre più stretti, a strapiombo sull’ippodromo e le terme, resto in silenzio, fino al muro del bosco scuro degli Astroni, che cinge verso l’alto il vigneto. Si vede che l’antica recinzione in tufo è stata costruita in due fasi, il muro aragonese fu rialzato dai Borboni per evitare che gli animali fuggissero dalla riserva di caccia: ora dalle brecce escono le volpi, di notte, assai ghiotte dei grappoli dolci in maturazione. Raffaele mi mostra i raspi nudi sulla pianta, sorride, in fondo fa parte del gioco. Dopo tre ore in giro nel vigneto, è il momento della cantina, un locale fresco e pulito coi tini in acciaio, e poi la sala di degustazione. Lello con la sua fissa per il medioevo l’ha pensata accogliente come una taverna de I pilastri della terra, con le panche di legno grezzo e il soffitto basso con le travi a vista, ed è qui che il figlio Gennaro, instancabile come il papà, ci fa trovare taralli e freselline, per gustare finalmente il Pér ‘e palumm’ di Agnanum, del quale tutta l’Italia parla.
Perché con il piedirosso dei suoi vigneti storici – un vitigno ritenuto buono per vinelli effimeri, che non lasciano traccia, da miscelare all’aglianico per tirar fuori qualcosa di buono – Raffaele è riuscito in purezza a produrre un rosso strabiliante, che ha ricevuto quest’anno i Tre bicchieri del Gambero rosso, e già in precedenza i 18/20 della Guida dell’Espresso, collocandosi oramai stabilmente nel gruppo di eccellenza dei vini campani. Con il suo lavoro visionario, Raffaele ha così arricchito di un nuovo protagonista la storia e la semantica dei rossi della Campania, accompagnando inaspettatamente all’aglianico un vino altrettanto nobile, complesso e profondo, che rimanda al Pinot nero e i grandi francesi. Il miracolo è che questa eccellenza assoluta la porti a casa con meno di quindici euro, mentre ce ne vorrebbero almeno quattro volte tanto per compensare il lavoro immane, non solo di pensiero, ma di braccia, di gamba e di spalla, che Raffaele e Gennaro profondono per la manutenzione dei terrazzi, delle sistemazioni idrauliche, per la pulizia e la prevenzione dei fuochi, la cura meticolosa del vigneto storico.
Questa manutenzione del paesaggio, questa produzione di bellezza della quale tutta la comunità cittadina si avvantaggia, è gratis, non viene compensata, e dovremmo interrogarci perché, a fronte dell’importanza di queste cose, non esista ancora in comune un assessorato all’agricoltura, uno sportello dove l’agricoltore urbano, questo cittadino invisibile alla politica e alla burocrazia, possa trovare risposta e aiuto per le sue specifiche esigenze, un sostegno minimo al suo lavoro agronomico, sociale e culturale. Torno giù pensieroso, le richieste per Agnanum fioccano, ma la produzione rimane limitata, venticinquemila bottiglie circa l’anno, assolutamente insufficienti a fronteggiare la domanda, rimane la realtà di una piccola azienda agricola familiare che produce, qui in mezzo alla città, una qualità di livello mondiale: perché alla fine, il piccolo campione in cui nessuno credeva, ha spazzato via i difettucci e ha vinto il Gran premio. Per tutto questo grazie, Raffaele. (antonio di gennaro)


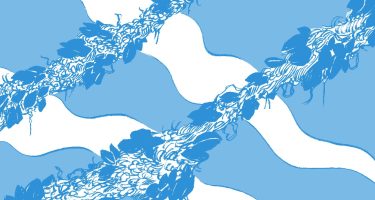


Leave a Reply