
Pietro Gargano è un giornalista del Mattino, oggi in pensione dopo oltre cinquant’anni di lavoro per il quotidiano di via Chiatamone. Lo scorso martedì ha presentato, al teatro Mercadante, l’ultimo dei sette volumi della sua Nuova Enciclopedia illustrata della canzone napoletana (Magmata Edizioni). Ne abbiamo approfittato per incontrarlo e parlare con lui del suo lavoro, della musica napoletana, e del suo lungo viaggio nel mondo del giornalismo.
Nella presentazione alla tua Enciclopedia si richiama esplicitamente quella di Ettore De Mura. Quali sono i punti di contatto tra le vostre ricerche?
De Mura è stato un eroe. Il suo lavoro è uscito nel ’68, quando non c’era computer né internet, e tutte le ricerche le ha fatte girando, sporcandosi le scarpe. Senza la sua opera non ci sarebbe stato nessun lavoro successivo. Certo c’è una differenza di metodo, connessa con i cinquant’anni che stanno in mezzo alle due cose. Le sue erano schede vere e proprie, mentre io ho fatto un lavoro in cui il giornalista prevale, soprattutto per gli autori che ritengo importanti, per i quali ho scritto dei lunghi articoli, dei ritratti, con un tentativo di valutazione critica. Ma una enciclopedia è una enciclopedia, ha un ordine alfabetico e un approccio informativo, per cui solo in coda ai volumi ci sono alcune sezioni monotematiche, appendici sui teatri, gli editori, e così via. In un certo senso il mio è un completamento del lavoro di De Mura, perché alcune figure si sono evolute, altre sono nate. Per esempio, ho fatto un tentativo di inglobare il mondo neomelodico, che forse è stato un errore, perché poi alcune parabole che sembravano avviate in una certa direzione non si sono rivelate tali.
È stata una scelta delicata…
Io sono convinto che il fenomeno neomelodico sia il riflesso di un buco nella cultura di questa città. La ragazzina di tredici anni che rimane incinta in un rione popolare, storicamente trovava i suoi cantori in Di Giacomo, Viviani, Bovio, poeti e narratori che si occupavano di quella Napoli. La stessa canzone di giacca non ha avuto una continuazione all’altezza della sua tradizione. C’è stata la canzone di malavita, che è un’altra cosa, e poi nulla. Anche se generalizzare è sbagliato… anche per la musica neomelodica. Per esempio, c’era una ragazza bravissima, Stefania Lay, con una voce di assoluto livello, che oggi fa la commessa in un negozio e non canta più. E lei ha cantato questa canzone, ‘A Libertà, con un testo protofemminista, un po’ rudimentale, ma forte.
Tra i “fatti nuovi” c’è il fenomeno hip hop.
Un fenomeno che meriterebbe strumenti di analisi critica adeguati, perché questi da anni stanno facendo i migliori versi in città. Sono gli unici autentici, c’è un racconto della realtà per come è. E musicalmente è successa una cosa straordinaria: a me sembra che la melodia che sta nella testa di ogni napoletano abbia preso il sopravvento, e siano usciti dei tessuti musicali molto belli.
Quanto tempo è necessario per dar vita a un lavoro di questa mole?
Io non me n’ero accorto, ma ci ho messo nove anni. Non ne potevo più francamente, ma sono contento di averla fatta. Dal mio punto di vista è stato un doppio tentativo. Il primo politico, nel portare al centro un “valore”, come quello della canzone napoletana, che non è un cascame folklorico, ma una forma d’arte popolare. Poi c’era l’idea di dare degli strumenti a chi se ne vorrà occupare un domani. Dal punto di vista del metodo ho avuto la fortuna che, da quando è venuto fuori il computer, ho cominciato a raccogliere tutto quello che potevo. E così quando ho deciso di fare questo lavoro avevo il vantaggio di un materiale già “organizzabile”. Ma la fase di accumulazione va indietro negli anni, prima avevo scritto un libro per Rizzoli, con Gianni Cesarini, che è un grosso critico non solo della canzone napoletana; e poi un altro lavoro per Selezione dal Reader’s Digest, con allegato una decina di nastri.
Uno spazio importante lo hanno due manifestazioni storiche per la diffusione della musica napoletana: la Piedigrotta e il Festival di Napoli.
L’importanza maggiore l’ha avuta la Piedigrotta. E se ne sa pure poco per quanto riguarda la tradizione più antica. De Simone, per esempio, è convinto che più che una sfilata di carri, all’inizio fosse una sfilata di carrette! Con i campagnoli che venivano dalla provincia a portare i broccoli, che alla fine si sfidavano a inventare e cantare. Proprio De Simone conserva una collezione di canti per Santa Maddalena, nati in queste occasioni, che sono di una bellezza senza pari. Oppure per dirne un’altra, anni fa, un amico che era un attore di sceneggiata, m’invitò a Montevergine per seguire il filone della tradizione che voleva si portasse la canzone più applaudita della Piedigrotta davanti alla Madonna, per eseguirla in presenza dell’abate. E vidi questi ragazzini delle più importanti famiglie dei suonatori di mandolini e di chitarre, che cantavano «Simme jute e simme venute, quanti grazie ca avimm’ avuto!» e poi dopo le canzoni nuove. Col tempo c’è stato un certo distacco da parte dei monaci, poi la guerra alla processione dei femminelli… Il Festival invece è stato un tentativo di portare sul mercato la canzone napoletana. Il primo si fa nel ’52, quando l’asse della capitale della musica era già spostata su Roma e Milano. Napoli prova a resistere, con la Phonotype e altre case discografiche, ma anche con i fascicoli della Piedigrotta, i giornali specializzati. In pochi anni il Festival diventa una cosa importante, e non è nemmeno vero che fosse deteriore da un punto di vista qualitativo, perché ci sono state canzoni bellissime. Anzi, puntando a un mercato non solo napoletano si cominciarono ad accogliere anche autori stranieri, ci fu uno scambio di esperienze. A mio avviso una delle canzoni più belle degli ultimi cinquant’anni è Sciummo, che è di Concina, un settentrionale. Poi gradualmente la cosa si deteriorò, nel ’71 si fece l’ultimo Festival, anzi si arrivò solo al livello delle ultime prove finché la televisione non ritirò le telecamere. C’era stata una sparatoria, a Santa Lucia, otto colpi di avvertimento contro un autore. E poi una guerra di carta bollata, per canzoni che erano state escluse senza essere visionate, anche se va detto che gli imbrogli li hanno sempre fatti. Con grande responsabilità dei giornalisti, che avevano monopolizzato la giuria…
È possibile individuare il più grande tra gli interpreti?
Il più grande per me è Pasquariello. O almeno quello che si avvicina più al giusto modo di affrontare la canzone napoletana. I tenori, a parte Caruso, cantano di voce, mentre la canzone napoletana è basata sulla poesia, per cui interpretarla significa coglierne il senso. Non a caso, Caruso era stato un posteggiatore e quindi un interprete vero, non solo dal punto di vista del sentimento, della pronuncia, dell’esposizione, ma anche della gradualità della voce. Il posteggiatore sa quando deve urlare, perché la sala è grande e rumorosa, ma sa pure che se sta interpretando una serenata per due innamorati, la stessa canzone va sussurrata. E in questo Pasquariello è insuperabile. Comunque le grandi voci sono tantissime. C’è stata una cantante eccezionale, Lina Resal, che morì a trent’anni e non ha lasciato molto materiale, o anche Elvira Donnarumma. Io sono appassionato dai riformatori, e quindi ci metto anche Carosone, straordinario pianista e uomo ironico, capace di smontare tutti i luoghi comuni della musica non solo napoletana; ma anche Peppino Di Capri, che quando nessuno cantava più la canzone napoletana l’avvicinò ai giovani, terzinandola. E poi i due più grandi interpreti prima di Pino Daniele, che sono stati Bruni e Roberto Murolo.
Sergio Bruni rappresenta oggi l’immagine della tradizione…
È la continuazione della tradizione, di una tradizione di confine, dove avvengono sempre le cose più importanti. Perché lui nasce a Villaricca, un posto che non era più campagna ma non è diventata mai città. Per cui riprese il canto a fronna, tra l’altro inguaiando varie generazioni di interpreti, che nel tentativo di imitarlo fecero schifezze mai viste, rovinandosi pure la voce. Con Bruni ho litigato tantissime volte. Aveva un caratteraccio, ma anche una dignità di sé straordinaria. Un esempio di rigore assoluto. C’è l’aneddoto della luna, che io racconto, emblematico del suo modo di lavorare.
“Un aneddoto esemplare del perfezionismo di Bruni lo racconta Nino Masiello. Nel ’68 Masiello dirigeva un concerto del maestro alla Casina dei Fiori. Bruni pretese, con educata fermezza, lo spostamento di un faro che, a suo dire, gli allungava il naso. Furono messi due faretti, ma anch’essi furono sostituiti. Tutto sembrava finalmente andar bene, ma a un certo punto il cantante strinse gli occhi e indicò un’altra luce di fronte. «Spostiamo pure quella», disse. Intervenne il suo segretario: «Maestro, chella è ‘a luna!»“. (da: p. gargano. nuova enciclopedia illustrata della canzone napoletana / I volume)
Nei tuoi lavori ci sono figure femminili di primo piano, a cui raramente viene attribuita l’attenzione che meriterebbero.
Da qualche tempo ho in testa l’idea di scrivere una storia della canzone napoletana al femminile. Forse questa mancanza è anche retaggio di antichi costumi, perché fino a un certo punto essere una posteggiatrice era vietato, ed essere una cantante era sinonimo di zoccola. La stessa Ria Rosa ha avuto solo successivamente una eco forte, il suo femminismo molto istintivo era quasi una rivincita. Nel periodo del café-chantant ci sono racconti di dietro le quinte in cui le sciantose, queste donne fatali, allattavano ‘o piccirillo dietro il sipario, e contemporaneamente connesso a loro c’era un mondo di sfide a duello, gioventù debosciata e nobile, suicidi, ammazzamenti. Finché arriva una donna brutta, forse addirittura insignificante, come Elvira Donnaruma, che riesce ad avere un grande successo e lo fa, come dice Cangiullo, altro grande autore di canzoni napoletane, “come un’anguilla di carne elettrizzata”. E infine c’è quel fenomeno straordinario di Giulietta Sacco, che ha avuto una carriera meno importante di quanto non meritasse. Inguaiata da un musicista, che se la teneva e la trattava malissimo. Poi ebbe una crisi mistica, la decadenza fisica. Ma la sua carriera è durata poco, interrotta nel momento migliore, quando si stava liberando dall’eco del fado che teneva in testa – perché st’Amalia Rodriguez, diciamoci la verità, è stata un incubo per tutte le cantanti napoletane…
Un’altra specificità sono le rivalità, quasi delle guerre musicali.
Sono una costante, anche se parecchie sono costruite. Nel senso che a disputarsi le simpatie del pubblico, i tifosi si moltiplicano di qua e di là. È il caso di Mario Merola e Pino Mauro, per esempio. Merola aveva una personalità dirompente, anche se Mauro cantava meglio. Però Mauro non aveva quella presenza ingombrante o la forza di Merola nello striscio. Un’altra, verissima invece, è quella tra Mirna Doris e Angela Luce, che dura anche ora che hanno più di settant’anni. Lì ci fu un fatto privato dietro, perché il compagno di Mirna la lasciò per Angela Luce, e lei rischiò di finire in galera, perché le voleva fare lo sfregio. Grandissime voci, ma se tu inviti a una delle due non puoi invitare l’altra.
Che opinione hai della sceneggiata?
Ho una buona opinione, anche se ha avuto bisogno di iscriversi a un partito per salvarsi, perché se non arrivava il Festival dell’Unità era morta e sepolta. Recentemente c’è stato Ottaviano, l’ultimo a portarla in giro con un po’ di successo, ma temo ci abbia rinunciato anche lui, ed è un peccato, perché credo sia un genere che abbia diritto di sopravvivenza. Certo, se uno si mette a leggere tutto col codice civile in mano è la fine. È una cosa che va contestualizzata, ma è un genere portatore di valori assoluti: la mamma, la gelosia, la vendetta, cose che stanno pure in Shakespeare. Quello della sceneggiata è stato l’ultimo genere ad avere un radicamento popolare vero. Anche durante gli ultimi tentativi, quelli di Geppy Gleijeses, vedevi nei teatri quelle reazioni istintive, la gente che alluccava: Accirele! Questa di Gleijeses, negli anni Novanta, era molto efficace, c’erano Pino Mauro e Mirna Doris, poi Ciro Capano, Antonio Buonuomo.
Su Mirna Doris hai scritto un libro, in cui la presenti come l’erede più importante della tradizione femminile.
Mirna è una mia cara amica, quel lavoro è stata una scommessa e credo sia una buona narrazione del suo personaggio. È una donna fragile ma tosta, con grandi valori. Ora sta cantando poco, dopo che ha fatto per una decina d’anni il programma di Limiti, con un successo straordinario. Andai con lei un paio di volte, perché Limiti mi chiese di scrivergli dei testi – poi lo fecero fuori – ma con Mirna non si riusciva a camminare per Milano, la gente la fermava ogni dieci metri.
In generale hai scritto diversi lavori biografici. Hai un metodo generale nel costruire un rapporto con la materia e la persona che racconti?
Quando ci si mette a lavorare alla biografia di una persona sarebbe importante costruire un rapporto più autentico possibile, ma non sempre è facile. Le persone che parlano per ascoltare se stesse non mi piacciono. A me piace ascoltare, ma non ascoltare solo quello che l’intervistato vuole. L’intervista non è un monologo. E quindi hai delle difficoltà, soprattutto con gli artisti, che oggi sono costruiti, hanno qualcuno alle spalle che gli suggerisce cosa dire, come muoversi, con chi parlare. Ovviamente dipende dallo spessore del personaggio che intervisti. Con Maurizio Valenzi è stata una tragedia. Noi lavoravamo così: lui raccontava, io prendevo appunti, scrivevo, e il giorno dopo rileggevamo. E puntualmente durante la rilettura lui alzava la mano: «Fermo. Non si può scrivere. Danneggia il partito!». «Ma ‘o partito nun esiste cchiù!», facevo io, perché il PCI era finito, e forse pure i DS. Allora subito: riunione di cellula. Prima telefonata: Giorgio Napolitano, per avere il consiglio massimo. Poi Geremicca, e tutti gli altri. Così si convocava questa riunione con gli ex capi operai delle fabbriche napoletane, che tenevano tutti ottantacinque-novant’anni. E che venivano chiamati per colpa mia a casa di Valenzi, dove votavano per alzata di mano se una cosa si poteva scrivere o meno.
È stato un lavoro molto travagliato…
L’ultima grande litigata, al termine della quale me ne andai, e poi fui richiamato per terminare il libro, fu per una cosa di questo genere, una storia molto efficace per il racconto di quello che era stato il PCI. È la storia di quando Maurizio fu arrestato, condannato all’ergastolo e trasferito in treno da un carcere diciamo decente, a un altro al confine con l’Algeria, la famosa “fossa del diavolo”. Nel frattempo, Liz, la moglie, era stata arrestata anche lei ma liberata, per avere distribuito materiale di propaganda. E allora il partito clandestino la avvisa, e le dicono: «Maurizio passa, in treno, a quest’ora da questa stazione per il trasferimento. Vai là e mandagli questo messaggio». Il treno si ferma nella notte, e Maurizio si affaccia in condizioni pietose: senza un capello, cadaverico, con i pidocchi che gli camminavano addosso. Lei lo vede, si scorda della parola d’ordine e scoppia a piangere. E il giorno dopo la espellono dal partito. Ho fatto una battaglia per scrivere questa cosa, e alla fine sono riuscito a infilarla. (riccardo rosa)


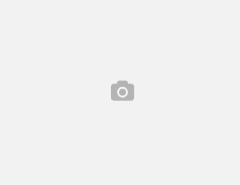


Leave a Reply