
Trentaquattro corsi di laurea che saltano, e sei sedi decentrate di atenei che scompaiono. La formuletta magica per indorare la pillola, neppure troppo in verità, è stata “processo di federazione degli atenei”. L’accordo sottoscritto la settimana scorsa tra la Gelmini e il governatore Caldoro insieme ai rettori delle università campane, però, sembra essere ancora una volta solo un fatto di tagli.
Qualche giorno fa, su internet, ho rivisto un filmato in cui parla proprio il ministro Gelmini, in una trasmissione televisiva, credo fosse Ballarò o qualcosa del genere. Il ministro esalta la sua riforma, in particolare per la grande operazione di razionalizzazione dei corsi di laurea: «Mai più corsi con cinque-sei iscritti, come quelli di giardinaggio, educazione permanente e psicologia del lavoro». Lo scorso gennaio, invece, se l’è presa con le «inutili amenità come i corsi di laurea in scienze della comunicazione». L’università italiana non può più sostenere sprechi del genere, è il succo, e di conseguenza si va tutti a casa.
A questo punto provo a soffermarmi sulla lista dei corsi eliminati dagli atenei campani. Innanzitutto, se è vero che ci ho messo cinque anni per prendere la triennale all’Orientale, e un po’ di esperienza l’ho quindi accumulata, mi pare di notare che almeno per quanto riguarda il mio ex ateneo, non si tratti di corsi così poco utili, e con così pochi iscritti. A cadere, all’Orientale ne sono ben dodici, tra cui informatica umanistica, plurilinguismo e multiculturalità nel mediterraneo (scelta interessante, considerato quanto sta accadendo in giro per il mondo), politica ed economia delle istituzioni, sviluppo e cooperazione internazionale (lungimirante anche questa), filosofia e comunicazione, politiche e istituzioni dell’Europa.
Mi ricordo di Rosario, che studia traduzione letteraria, e gli telefono per capire se sono io a sbagliarmi. «Per niente», mi risponde. «È un ottimo corso di laurea, e gli iscritti almeno negli ultimi due-tre anni non sono mancati». Quando gli chiedo quale sia la particolarità del corso, mi risponde che «permette un tipo di lavoro sui testi in lingue che in tutto il sud Italia sono poco studiate, a cominciare dalla maggior parte di quelle minori dell’Europa orientale. E per di più ci sono esami come quello di archivistica che sono molto specifici e i cui insegnamenti, con la scomparsa del corso di laurea, andranno perduti». È inutile dire, a questo punto, che quello di traduzione letteraria è uno dei corsi che dal prossimo anno non ci sarà più.
Provo a capire allora quale sia il criterio con il quale i corsi sono stati eliminati, se siano stati estratti a sorte, se sia forse una questione di gusti del presidente della regione o del ministro (al che, date le affermazioni di cui sopra, non mi stupirebbero le scelte fatte). Alla fine mi spiegano che è una questione di docenti: per quanto riguarda l’Orientale, per esempio, il 25% dei professori è andato o è prossimo ad andare in pensione l’anno venturo. Dal momento che i soldi per effettuare nuove assunzioni non ci sono, non avviene il cosiddetto turn over (non quello che è costato al Napoli la coppa Uefa, ma il ricambio generazionale dei posti di lavoro), e viene a mancare il numero legale di docenti per assicurare la partenza di un corso di laurea. C’è da dire, in ogni caso, che si tratta di una percentuale piuttosto alta, che include anche un discreto numero di prepensionamenti, da parte di docenti che evidentemente, avendone l’età, hanno preferito tirarsi fuori dal caos, piuttosto che osservare da dentro lo sfascio dell’università italiana. Per lo stesso motivo, a quanto pare, sembra che in consiglio di facoltà all’Orientale, si stia già parlando della possibilità di allargare il sistema del numero chiuso anche ai corsi di laurea triennale. Questo vorrebbe dire, ovviamente, vedere tanti ragazzi che escono dal liceo pensando di imparare il giapponese o lo swahili e che se non passano il test di ammissione si trovano davanti due strade: o vanno a provare altrove, o si attaccano al tram. «È come se ci trovassimo sotto ricatto», racconta qualcuno tra i pochi docenti che sembra soffermarsi in maniera critica su quello che sta accadendo. «Abbiamo troppi studenti e si potrebbe arrivare allo sdoppiamento di alcuni corsi. Questo richiederebbe l’assunzione di nuovi docenti, che però non può avvenire per i motivi che conosciamo tutti».
Un’altra interessante soluzione proposta dell’accordo è “la concentrazione dei poteri decisionali in materia di offerta formativa nelle mani di un unico organo federale”. A decidere il tutto, ovviamente, ci saranno i rettori, l’assessore regionale all’università e alla ricerca e un solo rappresentante degli studenti, che dovrà parlare (non si capisce come questo possa essere possibile) a nome dei rappresentanti dei singoli atenei, che già di norma, per come funziona il sistema, rappresentano poco e niente.
Continuo a scorrere la lista, e mi accorgo che in giro per la Campania non ci saranno più, tra gli altri: matematica a Torre del Greco e architettura a Cava de’ Tirreni; disegno industriale a Marcianise e medicina e chirurgia ad Avellino. Ancora, saltano, a Napoli: restauro, ingegneria aerospaziale, astrofisica e geofisica alla Federico II. Architettura e protezione dell’ambiente urbano, scienze politiche e scienze del turismo alla SUN.
«In realtà c’è poco da scandalizzarsi ora. Forse la parola “taglio” faceva meno effetto prima perché era soltanto un’idea. Ora che i soldi a disposizione questi sono, e da qualche parte dovevano levare, ecco che cominciano ad arrivare i provvedimenti concreti. Sinceramente, che cosa vi aspettavate?», mi risponde quasi stizzito uno studente, che dopo due anni di proteste contro la riforma, abbastanza in prima linea, ora non vuole sentirne più parlare, e aspetta di finire gli ultimi esami della specialistica per andare via dall’Italia.
Mentre lui già prepara le valigie, il ministro Gelmini – si legge nel comunicato stampa – “si è congratulato con gli atenei campani per la velocità con cui hanno recepito la riforma”. Già, ben fatto. (riccardo rosa)

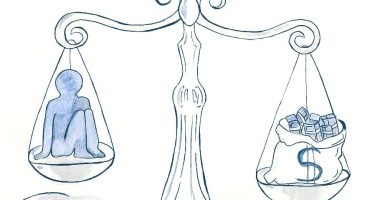



Leave a Reply