
Pubblichiamo a seguire un estratto dell’articolo Vivere e morire lungo la via Domiziana. Un diario di campo, scritto da Salvatore Porcaro e pubblicato nel numero 1 / ottobre 2018 della rivista Lo stato delle città.
* * *
1. Iniziai a frequentare Torre di Pescopagano – un insediamento turistico-residenziale a nord di Napoli – nel 2009. Allora raccoglievo notizie sulla vita dei ragazzi ghanesi uccisi a Castel Volturno il 18 settembre 2008 dal gruppo criminale guidato da Giuseppe Setola, luogotenente del clan dei casalesi, con lo scopo di intimidire l’intera comunità africana e convincere gli spacciatori a versare un pizzo sulla vendita della droga. Volevo raccontare la storia delle vittime e non quella degli assassini di cui le pagine dei giornali erano piene.
Gli attivisti del centro sociale Ex Canapificio di Caserta mi avevano presentato Peter, un ragazzo ghanese che avrebbe potuto aiutarmi a rintracciare amici e familiari delle vittime incolpevoli di quella strage efferata e razzista. Cominciai così ad andare con una certa frequenza a Castel Volturno. Raggiungevo Peter nei pressi della palazzina in cui abitava, sulla via Domiziana a pochi passi dal ponte dei Regi Lagni, e mi lasciavo guidare negli ambienti frequentati dalla comunità africana.
Durante questi lunghi pellegrinaggi visitai diverse case di donne nigeriane e ghanesi che vendevano prodotti alimentari e offrivano cibo e bevande ai connazionali; partecipai a feste private e cerimonie religiose, ed ebbi modo di incontrare amici e semplici conoscenti delle vittime, nei luoghi dove alcuni di loro avevano vissuto o lavorato. Con Peter scoprii un mondo che mi era ignoto, ma che abitava un territorio che sentivo profondamente mio per averlo frequentato fin da piccolo. Tra le tante cose che scoprii in quel periodo ci fu appunto Torre di Pescopagano. Capitò che Peter prese l’abitudine di andare a dormire a casa di un amico che vi abitava e mi chiedeva sempre più spesso di andare a prenderlo o accompagnarlo lì. Per un po’ mi lamentai, non capivo per quale ragione andasse in quel luogo così isolato e scomodo da raggiungere, poi mi abituai e incominciò a piacermi l’idea di percorrere ogni volta tutto il tratto di Domiziana che attraversa il comune di Castel Volturno, circa venti chilometri, e osservare la vita che lo anima. Mi sembrava, attraverso questo viaggio, di prendere le misure di quel mondo.
Una volta a Pescopagano mi capitava – stanco di attendere Peter che era sempre in ritardo – di scendere dall’auto e perlustrare la zona. Il viale privato, che dalla strada comunale conduceva nella lottizzazione servendo diverse case, terminava proprio davanti alla villetta a schiera di Peter. In quel punto c’era un’ampia area incolta che apriva la vista verso altre lottizzazioni tutte simili tra loro con strade al centro e lotti ai due lati. Un paesaggio costruito abusivamente, desolato e privo di qualità.
Per gran parte dell’anno la villetta a schiera, caratterizzata da un balcone circolare simile alla poppa di una nave, era abitata solo da immigrati che risiedevano nell’appartamento di destra. Nei fine settimana di primavera e in estate anche quello a sinistra veniva aperto e utilizzato da una famiglia di italiani che attrezzava il cortile con una piscina gonfiabile e dei giochi per i bambini, e vi posizionava un grande tavolo dove pranzavano e si intrattenevano per interi pomeriggi.
Osservavo con curiosità il contrasto tra le vite degli immigrati e quelle degli italiani, che emergeva con tanta chiarezza in quella casa bifamiliare. Ogni tanto chiedevo a Peter notizie sui vicini, con cui mi sembrava intrattenesse un rapporto cordiale, e più in generale sulle relazioni che aveva con gli italiani. E lui mi sorprendeva sempre esprimendo affetto, riconoscenza e rispetto per i napoletani. All’epoca sottovalutavo il fatto che, lavorando con gli italiani come manovale, Peter conosceva molto bene il proletariato e il sottoproletariato cittadino e aveva avuto modo di comprendere usanze, regole di vita e tradizioni locali, molto più di me che provenivo dal ceto medio e avevo avuto poche occasioni di frequentare quegli ambienti. Furono queste le prime lezioni che imparai a Pescopagano e che forse mi spinsero a ritornarci periodicamente.
2. Dopo aver ricostruito la storia dei ghanesi uccisi dal commando di Setola, rimasi in contatto con Peter e periodicamente tornavo a Castel Volturno e riprendevo a girare con lui. Per un lungo periodo non ebbi alcun progetto, mi interessava solo consolidare l’amicizia con Peter e con le persone che mi aveva presentato. Poi con la fine del dottorato – che mi aveva impegnato nella ricostruzione del conflitto tra lo stato italiano e la famiglia Coppola, condannata per aver costruito parte del Villaggio Coppola Pinetamare su terreni demaniali – decisi di dedicarmi alla raccolta delle storie di vita dei migranti per raccontare più a fondo e attraverso la loro voce la comunità africana di Castel Volturno.
Questa intenzione fu stimolata anche da due occasioni che si presentarono in quel periodo: il coinvolgimento in un progetto editoriale promosso da Napoli Monitor che, ispirandosi ai lavori dello storico americano Studs Terkel, voleva raccontare la metropoli attraverso le storie dei suoi abitanti; e l’invito a realizzare un numero monografico della rivista Communitas su Castel Volturno. Inoltre, avevo iniziato a insegnare urbanistica al Politecnico di Milano e seguivo diverse tesi di laurea che avevano per tema slum, favelas e baraccopoli in Kenia, Brasile e Benin. Ed ebbi l’idea di proporre a Sara, una studentessa con cui avevo iniziato a collaborare, una ricerca su quel tratto di costa che mettesse in luce le modalità con cui era stato trasformato e individuasse nuove strategie di intervento. Io l’avrei introdotta al tema e l’avrei seguita come relatore di tesi e lei mi avrebbe aiutato a raccogliere le interviste che intendevo realizzare.
La prima cosa che decidemmo fu di prendere una casa a Torre di Pescopagano, in modo da trascorrere un periodo di ricerca sul campo. Non fu facile trovarne una. Ci rivolgemmo a un’agenzia di custodia delle case di vacanza e ad altri intermediari, ma nessuna delle soluzioni che proposero ci convinse. Offrivano case malridotte senza corrente, gas e acqua potabile e chiedevano, per alcuni mesi estivi, l’equivalente dell’affitto annuale. Chiedemmo allora aiuto a Peter che ci presentò un italiano che affittava appartamenti agli africani. Abitava in fondo a un viale privato, dissestato e malfamato, con diversi edifici fatiscenti occupati da immigrati. Ci accolse nel suo appartamento situato al primo piano di una palazzina di sua proprietà dove conviveva con una compagna dell’est Europa. Gli altri appartamenti erano tutti abitati da africani.
L’uomo ci interrogò sui motivi che ci spingevano a Pescopagano e ogni volta reagì con diffidenza o sarcasmo a quello che gli raccontavamo. L’ipotesi di affittarci uno spazio fu liquidata velocemente con la motivazione che erano tutti occupati, ma ebbi la sensazione che non fu neppure presa in considerazione.
In seguito gli chiedemmo di raccontarci la sua storia. Ci disse che era originario della provincia di Benevento. Suo padre, negli anni Settanta e Ottanta, aveva costruito diverse palazzine a Destra Volturno e Pescopagano. Per un lungo periodo erano state affittate a famiglie italiane ed erano gestite da una persona del posto, poi erano accaduti alcuni episodi, mancati pagamenti e cattiva manutenzione, che lo avevano spinto a occuparsene direttamente e ad affittarle solo agli immigrati. Parlando di questa scelta ci teneva a sottolineare che tutto quello che faceva era in regola con la legge e ci mostrava i contratti di affitto e le denunce di variazione di residenza che presentava in Comune e ai carabinieri. Lo faceva perché sapeva che su di lui, e su tutti quelli che avevano fatto la sua stessa scelta, pendeva l’accusa di essere i responsabili del degrado dell’area, coloro che affittavano agli immigrati irregolari decine di posti letto in appartamenti inagibili, guadagnando cifre che mai avrebbero potuto pretendere dagli italiani.
Dopo quel rifiuto, ci rivolgemmo nuovamente a Peter chiedendogli se era possibile affittare una stanza in un appartamento abitato da africani. Trovammo così ospitalità presso un pastore pentecostale che viveva a Pescopagano con moglie e figli, in una casa situata in un viale privato tranquillo e curato dove abitavano stabilmente anche famiglie italiane. Attrezzammo la nostra stanza con due letti singoli, un tavolo da lavoro e un paio di sedie.
Una volta sistemati iniziammo la ricerca. La prima idea fu quella di registrare delle video-interviste in modo da avere un materiale più versatile, che potesse essere utilizzato anche per una mostra. Peter ci presentava degli amici, noi chiedevamo la loro disponibilità, poi raccoglievamo una breve intervista audio e sulla base di questa costruivamo la scaletta per quella video. Registrammo alcune interviste ma ben presto ci accorgemmo che era troppo complicato andare avanti in quel modo – non tutti erano disposti a mostrarsi in video e quando lo erano non si riusciva a creare quell’intimità che ci avrebbe aiutato ad andare più a fondo nelle loro storie –, così decidemmo di registrare solo o principalmente testimonianze audio.
Dopo qualche settimana di lavoro, purtroppo il rapporto con Peter cambiò radicalmente. Ci furono incomprensioni su appuntamenti dati e non rispettati, e a seguito dell’ennesimo rimprovero mi disse che non ci avrebbe più aiutato, che nessuno si poteva permettere di “comandare” lui che aveva attraversato il deserto e fatto un lungo viaggio per raggiungere l’Italia.
In realtà, Peter stava cambiando radicalmente. Insieme a un gruppo di amici aveva fondato un’associazione ghanese che, ispirandosi a quelle nigeriane, ambiva a formare un gruppo di potere locale rappresentando le istanze dei connazionali. Questo progetto lo rendeva meno espansivo e solare, più cupo e pieno di sé.
Se da un lato quel distacco mi amareggiò molto, dall’altro mi aiutò a costruire dei rapporti più diretti con altri immigrati. Iniziai a frequentare alcune case gestite da donne africane dove ebbi modo di conoscere molte persone. In mancanza di spazi pubblici questi luoghi protetti funzionavano come centri di aggregazione per l’intera comunità. Al loro interno era possibile mangiare cibi etnici cucinati al momento, bere e fumare, guardare la tv in lingua inglese e acquistare prodotti alimentari tipici. Molti di questi luoghi si animavano nel pomeriggio quando le persone tornavano dal lavoro e si fermavano lì prima di andare a casa, ma non mancavano persone che vi trascorrevano intere giornate. Mi capitava di vederli arrivare in tarda mattinata, dopo che si erano svegliati all’alba per raggiungere le rotonde in cerca di lavoro e non avevano trovato nulla. Erano case accoglienti per tutti, in particolare per gli ultimi, per coloro che avevano perso ogni speranza nel futuro, il cui progetto migratorio era fallito da tempo e che restavano in Italia solo perché non avevano la forza o il coraggio di tornare in patria da sconfitti.
Quell’estate incontrai anche diversi italiani impegnati a tutelare i diritti degli immigrati. In particolare, andai spesso a Casavatore a trovare padre Giorgio Poletti. L’avevo conosciuto qualche anno prima a Castel Volturno quando era responsabile delle Casa Comboniana che lui stesso aveva fondato. Mi raccontò di quando, di ritorno dall’Africa, aveva fatto un lungo giro nel sud Italia nei luoghi dell’immigrazione e alla fine del viaggio aveva scelto di fermarsi a Castel Volturno. Mi parlò delle difficoltà iniziali nel formare una comunità di fedeli, delle iniziative contro la prostituzione e la diffusione della droga. Mi raccontò l’impegno per difendere i diritti dei migranti e le iniziative di protesta contro la politica nazionale che furono tra le cause del suo allontanamento.
3. L’autunno e l’inverno successivi li trascorsi a editare il materiale raccolto. Alcune storie di vita furono pubblicate sull’annuario di Napoli Monitor e poi sul mensile, mentre il numero monografico di Communitas non fu mai pubblicato. La rivista smise di essere stampata e rifiutai la proposta di fare una versione digitale, che allora mi sembrò riduttiva e poco adatta al lavoro realizzato.
Il fallimento di quel progetto mi tenne lontano da Pescopagano per più di un anno, poi lentamente ripresi a frequentare quei luoghi, conobbi altre persone e raccolsi nuove storie senza l’urgenza di pubblicarle. Spostai l’attenzione su Destra Volturno, un insediamento contiguo a Pescopagano, ma separato da un’area umida detta “lago piatto”, trasformata negli anni Novanta in uno scolmatore di piena per raccogliere le acque del fiume Volturno in caso di esondazione. A differenza di Pescopagano, Destra Volturno era un territorio più denso e caotico e vi era una presenza ancora maggiore di immigrati.
A Destra Volturno abitava Lamin, un gambiano che era arrivato in Italia alle fine degli anni Ottanta. I primi anni li aveva vissuti a Napoli lavorando nei campi di pomodoro, poi aveva trascorso un periodo a Milano tra spaccio e tossicodipendenza. Infine era tornato a Castel Volturno dove, grazie all’aiuto dell’associazione Jerry Masslo, era riuscito a entrare in una comunità per disintossicarsi. Da allora frequentava l’ambiente dell’associazionismo di sinistra ed era stato inserito in diversi progetti sociali.
In giro con Lamin conobbi molte altre persone. A differenza di quelle conosciute l’anno prima, queste erano più sole, povere e con vissuti drammatici. Conobbi una donna, a cui era stata tolta la figlia, che si prostituiva nell’appartamento dove abitava; una mamma con tre figli avuti da altrettanti uomini che l’avevano poi abbandonata; una signora nigeriana che conviveva con un anziano italiano che si era trasferito a Destra Volturno contro il volere dei figli; un uomo solo che viveva in una casa abbandonata e raccontava di essere stato pilota di aerei negli Stati Uniti.
Per ricordare i volti delle persone che incontravo iniziai a fare dei ritratti. Prima o dopo l’intervista aprivo il cavalletto, ci mettevo su una macchina analogica di medio formato e scattavo alcune foto. Mi spingeva anche la volontà di documentare la loro esistenza e i luoghi che abitavano. Volevo conservare una traccia della loro presenza contro tutti coloro che negavano o sottovalutano il radicamento della comunità africana lungo la Domiziana e speravano in un ritorno al passato, quando quegli insediamenti erano luoghi di villeggiatura.
In quel periodo tornai spesso a Pescopagano a trovare le persone conosciute negli anni precedenti. Mi capitava di intrattenermi a casa di Gloria, un pastore che mi aveva introdotto nell’ambiente delle chiese pentecostali. Con il suo aiuto intervistai diversi pastori – americani, italiani e africani – e capii qualcosa in più sulle pratiche di quella religione che si stava diffondendo un po’ dappertutto e influenzava significativamente la vita dei migranti. Gloria abitava al secondo piano di una palazzina, ma trascorreva molto tempo in uno spazio al piano terra dove aveva un piccolo spaccio di prodotti alimentari e dove soprattutto accoglieva dei bambini che le venivano affidati dai connazionali. Alcuni di loro solo per la giornata, altri invece per periodi più lunghi. Era questa una pratica molto diffusa tra gli immigrati che lavoravano o che si erano trasferiti temporaneamente altrove in cerca di lavoro.
Ripresi i rapporti con Peter, ma non gli chiesi più di presentarmi altre persone. Il più delle volte lo incontravo per strada e andavamo a bere qualcosa insieme. Evitavo di programmare degli appuntamenti e lasciavo al caso l’opportunità di vederlo. Un giorno mi capitò di passare da casa sua e lo trovai con le gambe ustionate intento a medicarsi. Mi disse che si era bruciato con la bombola del gas, lo accompagnai di corsa al pronto soccorso e passai alcune ore con lui in ospedale prima che fosse dimesso.
Poi ebbe i documenti e partì per l’Africa con l’intenzione di rivedere la famiglia e sposarsi. Prima di andarsene mi fece vedere alcune foto della futura moglie con cui fino ad allora aveva avuto solo contatti telefonici. Nei mesi successivi lo chiamai spesso per sapere come stava e quando sarebbe tornato. La prima volta mi raccontò del matrimonio e mi disse che sarebbe stato lì ancora per un po’, poi fu vago e sfuggente.
Lo chiamai altre volte per conoscere i suoi programmi e continuai a ricevere risposte vaghe. Capii allora che qualcosa non andava, che forse non sarebbe più tornato. Chiesi notizie agli amici e iniziai a ricevere informazioni che mi sorpresero parecchio. Qualcuno mi disse che era stato fermato al confine tra il Marocco e la Spagna con diversi passaporti, un altro mi raccontò che era stato un informatore della polizia e che non sarebbe più tornato. Una donna, che era stata molto amica di Peter, mi confidò che non voleva più sentir parlare di lui perché aveva tentato di dare fuoco alla sua casa.
Un giorno venni a sapere, quasi per caso, da un amico in comune, che Peter era morto. La cosa mi colpì anche per il modo distaccato in cui mi fu raccontata. Non percepii un dispiacere, una mancanza in quelle parole. All’inizio non credetti alla notizia. Chiesi ad altre persone ma tutte mi dissero la stessa cosa e con lo stesso tono distaccato. Continuai a non crederci e pensai che quella voce era solo un modo per fuggire per sempre dall’Italia, cambiare identità e iniziare una nuova vita. Mi confidai con un’amica ghanese e le proposi di chiamare i familiari per sapere qualcosa in più. Il fratello confermò che Peter si era sentito male a casa, era stato portato in ospedale e dopo pochi giorni era morto. Continuai ad avere dei dubbi, non riuscivo ad accettare che un ragazzo forte e giovane come lui fosse morto così e chiesi a un’altra donna di chiamare e indagare sulla morte e sui funerali. Alla fine mi arresi e accettai la triste notizia.
La scomparsa di Peter fu solo la prima di una serie di perdite che hanno segnato la mia esperienza con la comunità africana del litorale domizio. Da quel momento in poi dovetti fare i conti sempre più spesso con il vuoto lasciato da una partenza inaspettata o da una morte improvvisa. Con quelle vite andavano via anche preziosi testimoni della storia locale, e lo facevano senza lasciare traccia, senza tramandare quelle esperienze ad altri, come se non avessero mai abitato quel luogo. La scomparsa portava via con sé anche la memoria. (continua…)

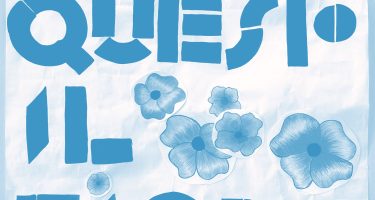

Leave a Reply