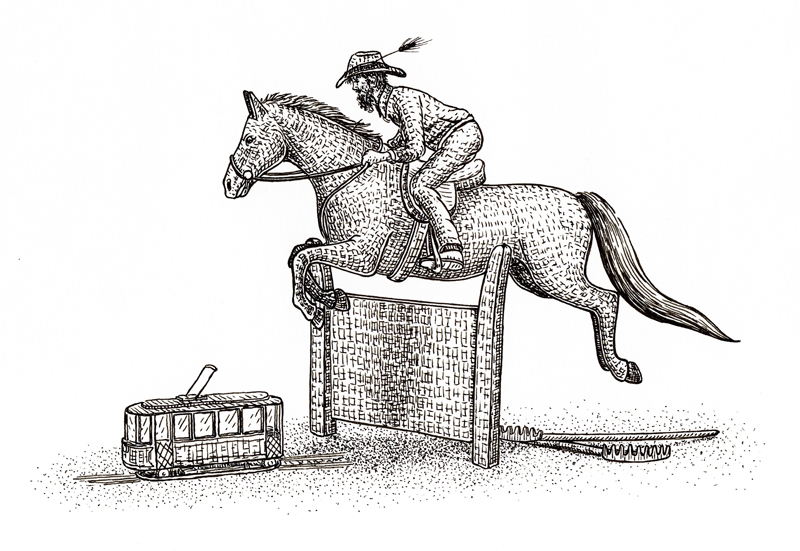
Che, da figlio di ferroviere, abbia goduto con il lasciapassare BK la titolarità di viaggi gratuiti su ogni treno in territorio nazionale fino all’anno 2000, resta oggi nella mia memoria una delle poche pietre miliari intorno a cui si addensano quei ricordi con cui ogni persona, nel franco dialogo con se stessa, sfaccetta la mitografia delle proprie origini.
E Campi Flegrei, la stazione del mio quartiere, che fu decorata con formidabili policromie di marmi e di stucchi per farne una consona porta ferroviaria entrando in città dalla direzione di Roma e oggi invece è mal sopportata come contenitore troppo grosso di un marginale traffico locale, ai tempi della mia gratuita mobilità ferroviaria accoglieva, in comoda alternativa alla stazione centrale, l’origine di molti appetitosi treni a lunga percorrenza, tra cui ricordo quello notturno che, via Roma-Tiburtina, arrivava in quella composizione fino a Venezia, dove si separava in due tronconi che nel mattino inoltrato proseguivano uno per Udine, l’altro per Trieste. Quante volte l’ho preso? Il BK e qualche mille lire in tasca, mi gettavo nel primo scompartimento fumatori senza ombra di prenotazioni, mi accendevo una Winston e, quando il convoglio partiva e nel tramonto sembrava passare attraverso le case di Cavalleggeri d’Aosta e di Bagnoli, sentivo viscerali vagiti di pura libertà, quella che non ha un oggetto, né si piega a uno scopo. Ero troppo libero, per desiderare un posto di cuccetta a prezzo di mercato. Ero figlio di ferroviere e salire su un treno e farmi portare fin dove volevo era un mio diritto naturale.
Il BK e qualche mille lire in tasca. Con lo stesso equipaggiamento ricordo d’aver anche dormito d’estate nella sala d’attesa della stazione di Passignano sul Trasimeno. Era aperta perché nessuno la chiudeva a chiave. Degli amici si erano sganciati. Un tetto me l’offrì la sala d’attesa di prima e seconda classe di quella minuscola stazione. Le regole c’erano, valevano per il pubblico pagante e valevano per me che pagare non dovevo e volevo solo attendere che si facesse giorno e sull’unico binario apparisse qualcosa che, stridendo e sferragliando, mi portasse da qualche altra parte.
Anni prima, nella mia immaginazione di bambino, l’esotismo dei romanzi di Salgari era messo alle corde solo dalla descrizione delle percorrenze dei treni com’era contemplata nel Pozzorario generale, il manuale degli orari ferroviari dalla copertina gialla da plico postale, che a casa mia era sempre a portata di mano, come l’elenco telefonico o La settimana enigmistica. Ancora fino alla metà degli anni Novanta il Pozzorario usciva a cadenza semestrale ed era acquistabile in edicola. A casa mia l’ultimo esemplare faceva sfoggio della sua ancora intonsa rilegatura già due settimane prima che il suo predecessore scadesse. Per mio nonno, come per mio padre, provvedere per tempo alla disponibilità del nuovo Pozzorario era naturale come pagare le bollette della luce e del gas per ottenere la continuità della fornitura. E al Pozzorario mi avvicinavo sempre con l’acquolina in bocca: sapendo dalla più tenera età di essere uno che viaggia gratis, lo aprivo e lo consultavo come se fosse una carta dei diritti. E lo mettevo alla prova senza esserne mai deluso. Una volta pretesi di sapere quante volte occorresse cambiare per raggiungere Fortezza/Franzensfeste in Alto Adige partendo da Metaponto e usando solo treni locali. E il Pozzorario generale aveva la risposta. Come sapeva dire il prezzo di un biglietto ferroviario spaccato alla 500 lire in base all’informazione dei chilometri da percorrere, del treno e della classe prescelti. Poi un giorno, senza che se ne celebrassero i funerali, il Pozzorario generale si estinse per sempre e la sua scomparsa assestò un duro colpo al mondo delle promesse mantenute.
In linea paterna, la mia famiglia era giunta con mio padre alla terza generazione di ferrovieri, dunque a casa mia la gratuità del trasporto su rotaia aveva solide radici fin dagli albori del Novecento. E così ci sono state donne della mia famiglia che ottennero di viaggiare gratis in treno prima ancora di poter votare. Come Anna Di Majo, prima moglie di mio nonno, madre di mio padre e dei miei zii, classe 1910 che, emancipandosi con un diploma magistrale, divenne rispettatissima maestra elementare e fino al primo anno di guerra pendolò quotidianamente tra Napoli e Battipaglia, in provincia di Salerno, raggiungendo gratuitamente la sperduta scuola dove insegnava con un treno dello stesso stato che la riteneva, in quanto donna, non abbastanza matura da poter scegliere i suoi rappresentanti, sia pure di un unico partito. Ripenso alle pagine scritte da Thomas Mann, che divennero le Considerazioni di un impolitico, in cui l’autore metteva in guardia dall’aberrazione di scambiare il diritto di voto per esercizio di libertà. Si può esercitare il diritto di voto senza per questo dimostrare di essere liberi, come si può essere liberi senza aver diritto di votare e Anna Di Majo, prima ancora di saperlo, lo era.
Nella memoria familiare restano archetipici di un’idea di rappresentazione del tempo libero incentrata sull’uso gratuito della rete ferroviaria i racconti che i miei nonni facevano delle gite domenicali negli anni Sessanta nelle città in cui il Napoli, di cui mio nonno era tifoso da sempre, giocava in trasferta. Arrivati a destinazione, convenivano un posto in stazione per ritrovarsi nel pomeriggio prima di ripartire e poi le loro strade si dividevano: nonno raggiungeva lo stadio e nonna visitava la città: un caffè, un cinema, un museo. Forte di queste abitudini, nonna irrideva una canzoncina di successo di Rita Pavone, che nel ritornello si lamentava che il suo uomo la domenica la lasciava sempre sola per andare a vedere la partita di pallone e diceva che questo era femminismo d’accatto pensato da qualche maschio banale. Che cosa poteva importare a lei, che aveva i suoi programmi e il suo daffare, se a suo marito, andando in visita in un’altra città, non veniva in mente nient’altro che visitarne sempre e soltanto lo stadio? Erano in gamba i miei nonni e funzionavano in modo efficace e spiritoso.
La nonna che si faceva beffe della hit di Rita Pavone era Rita Ricciardi, che pure negli anni del fascismo trionfante era stata una giovane maestra elementare e aveva fatto pendolarismo tra Napoli e Rodio di Pisciotta, località dell’immediato entroterra cilentano in cui, come raccontava ancora cinquant’anni più tardi, la sua autorità era pareggiata solo da quella del parroco e del farmacista. Ma finché fu pendolare, la nonna Rita i biglietti del treno se li dovette pagare e continuò a farlo fino al 1957, quando sposò mio nonno rimasto vedovo cinque anni prima. Fu senz’altro lei, persona esuberante e molto alla mano, ad avvicinare la famiglia all’uso sistematico dei servizi di ristorazione a bordo treno. Sono lieto di essere abbastanza vecchio da aver potuto ancora vedere, grazie a mia nonna, la vita delle carrozze ristorante in cui c’erano i cuochi coi cappelloni bianchi e il caposala, due figure che da una mezza eternità sono state sostituite da personale multiservizi che, non sapendo né cucinare né accogliere l’ospite, nel dubbio fa entrambe le cose.
Certo, ad aiutarli a funzionare in modo efficace e spiritoso, ai miei nonni veniva incontro anche il fatto di muoversi in un mondo che parlava più chiaro di oggi. Il galantuomo si vede a tavolino, usava dire mio nonno e quest’espressione, che lui mutuava da una pluridecennale esperienza nel gioco del tressette, oggi non può non arrivare addosso con un retrogusto arcaico, perché pretendere di parlar chiaro e di attenersi alla parola data è stato stornato da un pezzo dal novero delle virtù sociali, così come dagli slogan pubblicitari della ristorazione a bordo treno. (pasquale guadagni)
MEMORIE DI UN FIGLIO DI FERROVIERE


Complimenti. Anche nella mia famiglia, pur non essendo ferrovieri, c’era il culto del Pozzorario.
Ha descritto benissimo un pezzo di vita.
Contrariamente a Lei, i nostri amici figli di ferrovieri, non viaggiavano mai e la cosa ci faceva arrabbiare moltissimo, perché non viaggiavamo spesso e, chiaramente , pagavamo.
Errata corrige noi viaggiavamo spessissimo e chiaramente pagavamo