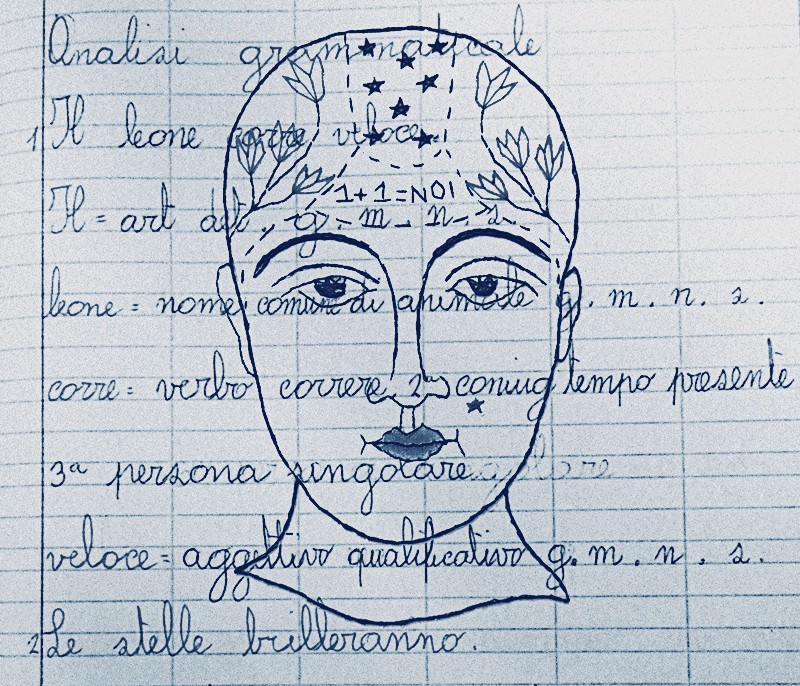
Nel 1981, a Ulassai, un paese dell’Ogliastra arroccato tra le montagne, nel nuorese, l’artista Maria Lai realizza l’opera Legarsi alla montagna. Chiamata per realizzare un monumento ai caduti, Lai stravolgerà la commissione dichiarando in seguito come il suo intento fosse quello di realizzare un’opera per i vivi piuttosto che per i morti. È questo un aspetto fondamentale di tutta la sua opera e della sua esistenza.
L’intera comunità partecipa all’evento: reinterpretando un’antica leggenda del paese, un nastro di stoffa celeste attraversa la città, lega le case l’una all’altra e il paese alla montagna. È un’immagine, questa, che rievoca certi scorci della Napoli odierna, dove quel che resta delle decorazioni per la vittoria dello scudetto, ridisegna le geometrie dei tessuti sospesi per la città, una trama che si mescola allo sgocciolio delle lenzuola sventolanti a festone. Sono prospettive comuni al centro quanto alle periferie, d’altra parte centro e periferia sono parti di una cosa intera. Quello che leggerete d’ora in poi è un andare e tornare tra due storie apparentemente distanti, è il viaggio di una spoletta che percorre e ripercorre un telaio, è un filo che si fa trama.
A Ulassai il monte Gelidi, la montagna più alta sopra il paese, è un po’ come il Vesuvio. La montagna e il Vesuvio sono doppi: simboli di sostentamento, ma al tempo stesso di morte poiché minacciano costantemente i territori ai loro piedi con il rischio di frane nel caso di Ulassai, o di eruzioni nel caso del vulcano. È questa una memoria collettiva quasi inconscia per gli abitanti di certi posti. È la stessa memoria dei napoletani, per i quali, come ci racconta Erri De Luca, il vulcano è un faro piantato nel sistema nervoso delle generazioni. La stella polare che tutti sanno riconoscere e indicare e da cui discende tutto l’orientamento. Il filo che tiene unite queste due esperienze apparentemente lontane, è un filo quasi mitologico, una sorta di filo di Arianna che serve a ritrovare la strada, l’orientamento, appunto.
Negli stessi anni in cui Maria Lai realizza quella che verrà poi definita la prima opera d’arte relazionale (dove il pubblico è partecipe della costruzione e della definizione dell’opera stessa), a Napoli viene edificata parte della periferia orientale della città. Siamo nel post-terremoto. Il 1985, per esempio, è l’anno in cui nasce il Lotto O, una sorta di quartiere nel quartiere, un complesso di edilizia residenziale pubblica lungo il viale delle Metamorfosi, di fronte al quale oggi è sorto l’Ospedale del mare, all’interno della più vasta area di Ponticelli.
I primi abitanti vi si trasferiscono nel 1989 in un gruppo di palazzi circondati da campi coltivati. È una superficie grande sei volte piazza del Plebiscito, con un’area scolastica abbandonata grande quanto lo stadio Maradona.
La parte est della città era in quegli anni (forse lo è tutt’ora), l’unica direttrice di espansione possibile. Era ed è, la parte di città più vicina alla montagna. In questi luoghi, dove l’unico orizzonte possibile sembra quello verticale, da alcuni punti, da alcuni palazzi, si intravede il mare di San Giovanni a Teduccio, da altri si vede il Vesuvio.
Si dice di Napoli che sia una città verticale, fatta di altezze e profondità. Un tempo si scavava per costruire; scavando e scolpendo lo spazio urbano, nascono città sotterranee; il materiale cavato si fa casa, le case si fanno città. È un gioco di pieni e di vuoti al quale partecipa anche il vulcano, scavato anch’esso. A volte queste cavità riemergono e la terra si apre, come accadde a Secondigliano. Le voragini rimangono nell’immaginario e nel gergo popolare, come un residuo di antica toponomastica. Ponticelli, per esempio, per gli adolescenti del quartiere è “il buco”, dal quale si tenta di evadere tra corse di taxi abusivi e circumvesuviana finché c’è.
Uscire dal buco è sì un’evasione, ma non farlo può rappresentare una diversa pratica dei luoghi, un esercizio che può mettere in crisi le retoriche delle identità locali. È questo il lavoro di diverse organizzazioni del posto. Ne è un esempio l’esperienza di Trerrote (Teatro Ricerca Educazione) e dell’associazione Maestri di strada, nata nel 2009 come evoluzione del progetto Chance, la scuola della seconda opportunità raccontata nel libro di Carla Melazzini Insegnare al principe di Danimarca.
Qual è allora il nesso tra l’esperienza sarda di Maria Lai e quella della periferia napoletana. Lai aveva visto nell’arte un potere terapeutico. Un’operazione politica la sua. Filiberto Menna, storico dell’arte, scriverà che “l’arte è riuscita là dove religione e politica non erano riuscite. […] Maria Lai ha saputo restituire la parola a un intero paese e rendersi partecipe della memoria e dei fantasmi della gente comune, aiutandola a liberarsi della parte distruttiva di sé e ad aprirsi con disponibilità nuova al colloquio e alla solidarietà”.
Prendere in prestito il titolo di un’opera di Maria Lai, non è quindi un caso, ma un tentativo di emulazione, un voler riproporre quell’esperienza per provare a raccontare il territorio con la voce di chi abita questi luoghi, con le parole degli adolescenti che vivono le periferie e si ritrovano a tessere relazioni, a cucire il mondo, talvolta aiutati proprio dalle associazioni del territorio.
Da qui in poi a parlare saranno i racconti degli adolescenti delle periferia est della città. Il tentativo sarà far parlare i muri, le pietre, legare le storie l’una all’altra con un nastro immaginario, annodarlo per creare legami e poi legarlo allo montagna. Provare a tradurre i fili, i tessuti, simboli di una scrittura incomprensibile, provare a tracciare una strada dove la strada è quasi una residenza. Il tentativo sarà “restituire la parola” al quartiere, alla città, alla gente comune. L’obiettivo sarà di parlare ai vivi e farli parlare. (caterina guerrieri)
IL BUCO
Il buco, dove son caduti migliaia di corpi tremanti
Il buco, dove oggi sono le anime a tremare.
Il buco, nel quale la gente c’è finita per mano della natura
E per colpa della pistola resta.
Perché dove non c’è nulla se non violenza
Non si può vivere senza.
Chi vive nel buco non può vedere le rose
Anche se il terreno è fertile
Perché non si riconosce la bellezza se di spine si è circondati.
E allora per diventare importanti
Si è costretti a fare cose agghiaccianti.
Scalare le pareti è difficile, quasi impossibile
Perché è più facile continuare a scavare piuttosto che scalare.
Ma nonostante tutto qualcuno ci prova,
Perché alzando la testa la luce si scova.
E allora con le unghie ci si aggrappa
Ai muri grigi di cemento armato
E si cerca di risalire, nonostante l’amianto.
E Si perdono persone.
E si perdono cose.
E ci si chiede “ma ne vale la pena?”
Scappare dalle anime in pena.
(arianna dentice, laboratorio di scrittura e teatro / maestri di strada)


Leave a Reply