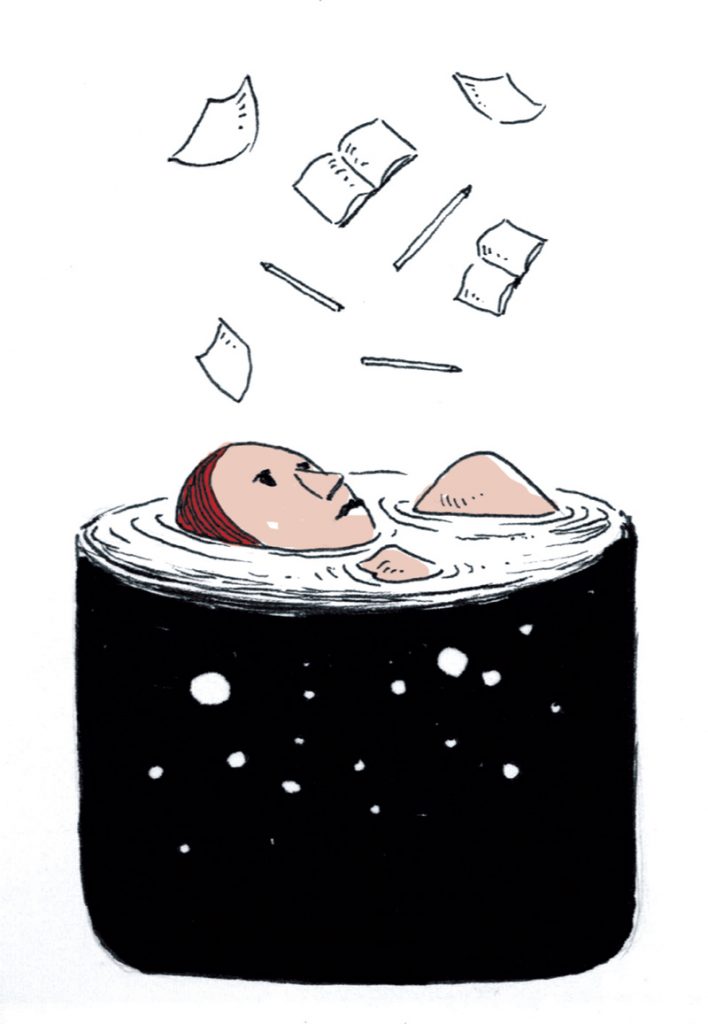
Come tutte le periferie dell’area metropolitana, il Rione Traiano si trova periodicamente sotto i riflettori, quasi sempre in concomitanza con accadimenti di cronaca nera. Per qualche tempo la stampa e l’opinione pubblica si ricordano dell’esistenza di questi enormi ghetti, ne denunciano la massiccia presenza malavitosa, si mostrano indignati per le condizioni di abbandono in cui operano la scuola, le associazioni e tutte le persone che provano a restituire a quei luoghi una dimensione più umana. Ma la denuncia è sempre fine a se stessa, tanto più che la politica se ne infischia, salvo qualche dichiarazione d’intenti tanto vaga quanto estemporanea. Il quartiere e i suoi problemi passano di moda nel tempo necessario a chiudere la pagina di un giornale, come se quelle vite trovassero senso solo all’interno del racconto predeterminato che del quartiere si intende fare.
Qui raccontiamo le storie di alcuni abitanti del Rione Traiano. Persone che lavorano o sono disoccupate, studiano o cercano un posto dove andare a dormire, insegnano oppure organizzano associazioni. Senza pretesa di dividere i buoni dai cattivi, ma cercando di far emergere le esistenze quotidiane di chi il rione lo abita, con tutte le infinite sfumature che si trovano nello spazio che esiste tra il bianco e il nero.
Angelo Tarantino, un reduce
I democristiani, il “demonio-cristiano” li chiamavo io, dicevano che il Rione Traiano doveva diventare la “città satellite”. Quando facevamo servizio speciale al consiglio comunale, io li ascoltavo mentre discutevano di quello che ci dovevano fare qui. Ognuno che è venuto ha cambiato l’idea di quello precedente, per far vedere che lasciava qualcosa. Il risultato è che hanno fatto sempre peggio del progetto iniziale. Questa piazza è dedicata a Ettore Vitale, presidente dell’Istituto Tecnico del Risanamento. Io sono venuto ad abitarci nel ’63, quando era tutta terra battuta, c’erano solo pietre, poi hanno cominciato a costruire le case e tutto il resto. Mi ricordo che appena fatta la piazza misero delle piante basse molto belle ma la gente non era ancora pronta a vivere in città, non era pronta alla civiltà, i ragazzini se le mangiavano e le dovettero levare.
Il progetto originale della piazza non è stato rispettato: prevedeva la chiesa, che in realtà è l’unica cosa che è stata fatta perché i preti non l’hanno mollata, però doveva starci pure il sottoservizio, la cripta diciamo, e non l’hanno fatta perché i soldi sono finiti; oppure qui dietro, dove stava il centro meccanografico, doveva esserci la pretura, e nemmeno l’hanno fatta perché venne Valenzi e disse che là ci doveva stare per forza il centro, perché “il progresso, la tecnologia era importante”, quando poi lo potevano fare cento metri più avanti, non succedeva niente. Qualche anno fa la piazza è stata rimessa a posto, e così d’estate scendo a prendere un po’ d’aria, incontro sempre qualcuno, faccio una chiacchierata. In questo posto ci ho sempre vissuto bene. La gente mi conosce e mi rispetta, non come poliziotto ma come persona per bene. Io dico sempre che ogni medicina ha la sua controindicazione. Questo quartiere poteva essere molto migliore, le medicine le hanno pure pensate, ma le hanno somministrate male, così sono rimaste solo le controindicazioni.
Fra tre mesi compio novantatre anni, ho i miei acciacchi, ma non mi posso lamentare. A Norimberga pesavo quarantatre chili con tutti gli zoccoli di legno al piede. Sono stato prigioniero dei tedeschi al campo 13 A. Poi a Ravensrbuck, a lavorare in miniera. Ci mettevano il lume a gas alla gola, e: «Raus!», sopra ai vagoni. Ci mandavano dentro la montagna, a mille e quattrocento metri sotto terra, ma quando avevano detto «Raus!» non è che si discuteva. Quando uscivi, ti facevano passare il materiale da un vagone all’altro, i metalli dovevano essere portati a Lipsia, dove c’erano gli altoforni che cacciavano rame, bronzo eccetera. E abbiamo fatto campo-miniera, miniera-campo fino a quando vennero gli americani. Noi pensavamo che era finito il lutto, la tragedia, ma erano peggio dei tedeschi. Appena arrivati cominciarono a fare strage delle donne del posto, Ravensburck era un campo in cui c’erano molte donne. Noi in baracca sentivamo le urla delle tedesche stuprate giorno e notte dai soldati americani. Piangevano, chiedevano pietà, l’avevo imparata a memoria quella parola: «Gnade!», non la dimenticherò mai. Poi ci diedero il via libera e alcuni di noi si avviarono a piedi verso il Brennero, io decisi di aspettare perché già avevo camminato abbastanza.
In Italia, non si capiva più niente. Tutto distrutto, gli americani che facevano il comodo loro, i fascisti che erano diventati comunisti, era un altro mondo. Io ero partito ragazzino, ero cresciuto sotto il fascismo e avevo visto solo quello. Facevo le scuole ad Avellino, dove sono nato, con la maestra che mi mandava a casa perché non tenevo i soldi per la tessera. Papà non lavorava, dato che era socialista, e comunque non se la sarebbe presa mai, la tessera. Mio padre ha fatto tutti i mestieri, è andato in disgrazia perché antifascista. Per un periodo, c’era uno zio di mia madre che era tornato dall’America dove aveva fatto un sacco di soldi con la Mano Nera e una volta in Italia si mise a lavorare nel commercio della frutta con gli Stati Uniti. E così mio padre si mise nelle ciliegie insieme a lui. Io un’opinione politica non l’avevo, un po’ perché ero cresciuto nel fascismo, un po’ perché tenevo diciassette anni quando mi hanno richiamato e sono partito soldato.
Rimpatriato dalla Germania sono stato un anno a casa, sperando di trovare un lavoro, finché non trovando niente ho deciso di arruolarmi in polizia, come reduce combattente, quindi senza dover fare concorsi. Andammo a Roma, alla caserma vicino alla stazione e c’era un amico che ebbe la pensata di farci scrivere come preferenza la polizia di frontiera, perché voleva essere mandato al Brennero, dato che avevamo imparato il tedesco e secondo lui era più facile essere presi. E così facemmo. Con noi c’era un altro amico che teneva famiglia, non si poteva muovere e quindi mise un altro ramo di polizia per farsi destinare in un posto non troppo lontano. E invece quando escono le destinazioni, a noi ci mandano a Napoli, alla polizia di frontiera che opera dentro al porto, e a questo poverino lo sbattono in Sicilia, con la moglie e i figli. Però poi la fortuna ha girato pure a lui perché ha lasciato la polizia, si è messo a commerciare e ha fatto un sacco di soldi.
Nel porto di Napoli ci ho lavorato dal 1945 fino a quando non ho fatto il concorso per sottoufficiale e mi mandarono a Caserta, all’inizio degli anni Sessanta. Nel frattempo avevo conosciuto mia moglie e mi ero sposato. Lei è nativa di Nola, ma teneva uno zio, il fratello della mamma, che era stato un caporione fascista, che abitava nel Vasto e non aveva figli. Lei lo andava a trovare spesso per dargli una mano con la casa e in quella casa ci siamo conosciuti, perché questo zio e la moglie erano amici della famiglia di un mio collega. Dopo la prima volta non l’ho vista per un anno, finché non ci rincontrammo per caso, sempre a Napoli, e ci fidanzammo. Una volta fidanzati lo zio fascista ci fece la proposta di andare a vivere con loro, perché all’epoca si usava tra diverse famiglie di dividere le case. Mia moglie li avrebbe accuditi e loro ci davano in cambio il vitto e l’alloggio. Lei non era troppo convinta, però mio suocero ci fece riflettere che un domani quella casa gli zii l’avrebbero lasciata a noi e accettammo. Anche perché case non se ne trovavano, era difficile sistemarsi.
Una sera mia moglie non volle tornare da Nola perché sua mamma non stava bene. Io rientro a casa e lo zio mi dice che ce ne dobbiamo andare, perché loro volevano essere accuditi e mia moglie “non ci teneva”. Solo che trovare una casa era impossibile e decidemmo che lei sarebbe rimasta a Nola dalla mamma e io mi sarei accasermato allo scalo marittimo. Quando potevo uscire, tanto ci vedevamo. Gli zii però capirono che così sarebbero rimasti soli, e quando mia moglie tornò da Nola dissero che potevamo restare. Ma a quel punto eravamo noi che ce ne volevamo andare.
Per prima cosa feci la domanda all’Ina Casa, avvisando mia cognata, che era suora e stava a Roma, a Regina Coeli. Lei lo disse alla madre superiora, che era la zia del dottor Servidio, il segretario della DC di Napoli, e ci raccomandò a lui per aiutarci. Così vado da questo Servidio che mi manda da un ingegnere all’Ina Casa per vedere che cosa si poteva fare, perché le richieste erano migliaia. All’Ina Casa mi dissero che Servidio o non Servidio loro non potevano farci scavalcare le liste, ma che se una possibilità c’era noi dovevamo creare le condizioni per rientrare tra gli “aventi diritto”. La cosa migliore per essere aventi diritto era avere un nucleo familiare che già viveva in qualche posto in cui non si poteva vivere: una cantina, un buco o qualcosa di questo genere. Insomma, ci disse di trovarci una cantinola qualsiasi, farci la residenza fittizia là dentro e aspettare. Una cantina in effetti la tenevamo: quella degli zii all’Arenella. Stava sotto il livello stradale, senza la cucina, senza niente, e così io andai a fare le pratiche per la residenza, tutto falso naturalmente. Quando arriva l’ispettore, giustamente non ci crede che abitavamo là, con un bambino piccolo, e così mette a fare le indagini a un brigadiere, un certo Acerbi. Un giorno mentre questo Acerbi si stava pigliando il caffè, un ragazzo che portava il latte e ci conosceva ma non sapeva dell’imbroglio, gli raccontò che noi abitavamo dagli zii e nella cantina non ci entrava mai nessuno. Avevamo perso le speranze, però chissà come stabilirono che anche se non vivevamo nella cantina, comunque quella degli zii non era casa nostra, e ci misero come aventi diritto.
La prima casa che ci assegnarono era a via Consalvo, a Fuorigrotta, ma non ci potemmo andare perché l’impresa era fallita e c’erano dei problemi. Nel frattempo i miei suoceri si erano fatti anziani e allora io gli dissi se volevano venire a Napoli, però dovevamo trovare una casa più grande che andava bene per tutti. Mi misi a cercare e la trovai alla Loggetta, una casa di quattro stanze, e la scambiai con il tizio che ci stava dentro, dandogli la nostra a via Consalvo, che intanto si era sbloccata. Ma là non ci troviamo bene, perché sotto di noi ci stava una famiglia un poco particolare, che il padre andava con la figlia: questo aveva avuto due figli con la figlia sua! E la moglie si era fissata con me, mi aspettava fuori le scale: «Io nun c’ha faccio cchiù, aiutateme!» e faceva una scenata dentro al palazzo. Così decisi che ce ne dovevamo andare.
Un giorno un fornaio della Loggetta mi manda a chiamare, mi porta al Rione Traiano e mi presenta a tale Cianci, dell’ufficio vendita del Risanamento. Cianci mi disse che ci stava una casa molto grande e molto bella che si doveva vendere, però l’acquirente aveva fatto il compromesso ma non aveva rispettato i termini e la casa era rimasta invenduta. Così io mi presi questa casa cacciando nove milioni uno sopra all’altro e ci trasferimmo nel Rione Traiano, in una casa che aveva delle comodità che non avevamo mai visto, a cominciare dall’ascensore. In questa casa ci sono rimasto volentieri e ci sto ancora oggi: in questa zona del rione le persone sono per bene, gente che lavora. Con gli anni l’abbiamo divisa, affianco a me ora ci abita mia figlia con la sua famiglia, e i suoi figli sono cresciuti bene in questo quartiere così trattato male.
Dopo aver fatto lo scalo marittimo ho fatto il sottufficiale, e sono stato in vari commissariati nella zona bene di Napoli. A Chiaia soprattutto, dove ho fatto lavoro d’ufficio, con la polizia giudiziaria. In effetti io per strada ho lavorato solo al porto, poi sempre con le pratiche. Molta gente del quartiere per anni nemmeno lo sapeva che lavoro facevo, che uscivo la mattina e rientravo la sera, non mi vedevano proprio. Al porto invece era un’altra cosa, una vita pesante e pericolosa, si controllavano i passaporti, le merci, si doveva fare la guardia agli scali, pure di notte. Una volta pigliai una brutta broncopolmonite, ma era una cosa che alle guardie che lavoravano al porto succedeva di continuo. Quando soppressero i commissariati, da Chiaia mi mandarono al secondo distretto a Santa Lucia. Lì pure ho lavorato bene, tanto che quando sono andato in pensione i funzionari mi chiedevano se volevo continuare a dare una mano. Però siccome la mia sedia – nel frattempo avevo fatto un po’ di carriera – già se la stavano bramando in tanti, io dissi ai funzionari che non era cosa e dal 1983 mi sono goduto la pensione. (riccardo rosa)


Leave a Reply