(archivio disegni napolimonitor)
All you can eat, ovvero: tutto quanto riesci a mangiare in cinquanta minuti. È questo il nuovo album degli Slivovitz, un percorso a zig-zag nell’apparato digerente del ciuccio da sempre simbolo del gruppo napoletano – per l’occasione disegnato da Rak, dopo quello ritratto in foto sulla copertina di Slivovitz e l’altro dipinto da cyop&kaf su quella di Bani Ahead. Un disco che comincia con una notte persiana e culmina in un oblio che resetta le sensazioni di quasi un’ora di musica.
È un concept-album, in un certo senso, All you can eat, sebbene i pezzi siano stati scritti in momenti diversi, in tracce separate e non in presa diretta, e non siano nemmeno tutti completamente inediti (anche se tutti, per la prima volta, compaiono su un supporto compatto). È allo stesso tempo un’abbuffata incontrollata e una colonscopia sonora (indolore: lodato sia l’Ipnovel, che annebbia e confonde ma non lascia dimenticare del tutto); un viaggio a ritmo serrato tra le ans(i)e intestinali e quelle musicali, che inizia col primo boccone e termina con l’ultimo bicchiere; uno stomaco che reclama hangover da colmare e torna a riempirsi quando la strada sembrava ormai in discesa, con un curry alla tedesca (cinque minuti e quindici per palati fini), che lascia cadere chi ascolta, sfinito, appunto, nell’Oblio.
All you can eat è il quarto disco degli Slivovitz, band che raggiunge quest’anno il traguardo di un decennio e un lustro di attività (con il primo album fuori nel 2006), seppure le formazioni siano state cangianti, nel corso di questo lungo cammino. È probabilmente il più rock, forse il meglio amalgamato (si veda: “organico”, giusto per rimanere in tema), tanto da farsi immaginare, a tratti, colonna sonora di un Umberto Lenzi o sceneggiatura musicata di uno Scerbanenco. Senza dubbio è il “più perfetto”, da un punto di vista stilistico: un album senza sbavature, dalla prima all’ultima nota, ma di una perfezione formale che quasi nulla sacrifica ad anima e personalità.
Per allestire il banchetto, d’altronde, i sette cuochi (e commensali) ci hanno messo quattro anni. In questo tempo hanno rielaborato, ripensato, litigato, dimenticato, ripescato e ricucito. Hanno accentuato alcune sonorità senza accantonarne altre, hanno suonato un po’ da Goblin un po’ da Napoli Centrale, o forse oggi, dopo quindici anni, è lecito dire semplicemente da Slivovitz. Hanno ripercorso a suon di bassi e chitarre (molto più presenti, rispetto al passato) i propri (baro)traumi (o: La zappa sui piedi, di Santangelo, voce e sax). Hanno riletto con trombe e violini, armoniche e batterie le storie dimenticate, rendendo omaggio, per esempio, con la traccia numero quattro (Passannante, di Riccardi), all’anarchico lucano che, nella Napoli di fine Ottocento, tra via Rosaroll e via Carbonara, tentò di accoltellare Umberto I, finendo poi per morire da folle, tra carcere e manicomio. È proprio questo pezzo l’apice ritmico del disco. Il punto in cui l’andamento, in crescita costante dall’inizio, cambia, ri-discendendo lentamente e preparando chi ascolta (si veda: “mangia”) alla dolce chiusura. Non prima di concedersi un ultimo sussulto digestivo con Currywurst, che è probabilmente il brano più riuscito di questo All you can eat. Un album di sola musica, che non spreca una parola, talmente riuscito da non pagare – come talvolta accade – nemmeno lo scotto di essere troppo riuscito. (riccardo rosa)

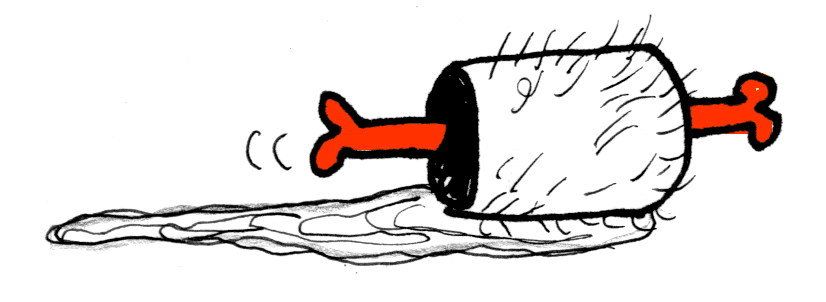




Leave a Reply