Una volta c’era il Piper. Una volta c’erano le discoteche degli eccessi, i bottiglioni di Champagne, la chioma unta di De Michelis che svolazzava nelle notti del potere romano. A Napoli le notti della Mela dove si incontravano i chiattilli, figli della borghesia partenopea e quelli che volevano somigliare a loro a tutti i costi. Gente che faceva la cresta sulla spesa alla mamma o si metteva a vendere il fumo per racimolare i soldi per una serata nei locali da ricchi. Le discoteche della Napoli bene, il Tongue a via Manzoni, con le file dei papà in Audi e Mercedes che attendevano i pargoli all’uscita. I ragazzi dei licei privati con il maglione sulle spalle e la coca da vendere nei bagni. Roba da ricchi. Ma con numeri contenuti.
Negli anni Novanta crebbero soprattutto in provincia discoteche enormi che, sul modello della riviera romagnola ogni sabato ingoiavano migliaia di ragazzi in cerca di sballo. Era l’epoca dell’house, le notti costosissime dei dj alla moda al Metropolis, al Cube, a Mugnano. Una serata, tra ingresso, drink, benzina, polverine e spese collaterali poteva costare quanto uno stipendio. Tempi lontani, a quanto pare. Mentre, infatti, i media si affannano ancora a dipingere le discoteche con la trita immagine di “inferno dei giovani”, dopo la morte di un ragazzino al Cocoricò la scorsa estate, pare che il mondo delle discoteche non sia più centrale, nella notte dei giovani italiani. Almeno sui grandi numeri. Sembra, infatti, che la crisi abbia investito anche quel mondo, con i locali dimezzati dai cinquemila circa della metà degli anni Novanta ai duemilacinquecento di oggi. Per i gestori dei locali italiani la crisi ha investito il settore decretando la necessità di tagli a fronte delle numerose chiusure, addirittura uno su tre a Milano. Quando si parla di aziende del ciclo produttivo “classico”, la chiusura richiama immediatamente (e giustamente) una riflessione sull’indotto, cioè quel volume di affari collaterale all’azienda che mantiene piccole realtà satellite e i relativi lavoratori con famiglia a carico. Nel caso delle discoteche è ovvio intuire che si tratti dello stesso problema, e che il calo di presenze, del venti per cento circa secondo l’Associazione italiana locali da ballo (Silb), si traduca in taglio di personale, forniture di alcolici e analcolici, servizi di sicurezza e vigilanza, imprese di pulizia. Ma anche barman, camerieri, tecnici e ballerine. Un popolo di lavoratori silenzioso e non rappresentato che nell’indifferenza dei media vive e lavora e finisce schiacciato dalla crisi economica.
I gestori, dal canto loro, reagiscono, o provano a farlo, accompagnando ai tagli guizzi d’inventiva tipo l’ape-cena che con trenta o trentacinque euro abbina la possibilità di cenare al buffet per poi ballare; altre iniziative più improbabili come il giro in limousine col logo del locale, che pare costi centoventi euro all’ora e riscuota anche un certo successo. Follie della crisi. A ogni modo, oltre ai tagli sul personale e alla riduzione delle forniture del famoso indotto, il calo degli ingressi e la regressione del modello di discoteca fondata su eccessi e grandi spese, investe anche elementi qualitativi dell’offerta. Molti, infatti, per fronteggiare la crisi hanno introdotto l’ingresso gratis, che significa provare poi a recuperare una parte dei guadagni mancati effettuando un ricarico sulle consumazioni e il conseguente crollo della qualità dei drink offerti. L’altro consistente taglio viene effettuato sull’offerta musicale, riducendo gli eventi con personaggi dal cachet da quotazione in borsa, il che a dire il vero, non per forza vuol dire calo della qualità, ma che per i gestori e gli utenti dei locali è un passo indietro. Significa finire fuori dai circuiti “che tirano”.
Discoteche in crisi, quindi, riduzione dei grandi palcoscenici degli anni passati anche se resistono, intramontabili, roccaforti come Ibiza e la Riviera. Rispetto al passato, però, si osserva il moltiplicarsi di versioni differenti del “nightclubbing” in luoghi ameni come la pedana in spiaggia, il discopub (per la verità presente come ambiente notturno secondario e leggermente “nerd” anche vent’anni fa), il chiringuito e, addirittura, il revival della festa in casa, un classico vintage.
Una lettura complessiva sulla crisi delle discoteche fatta dai gestori e dai media risulta in ogni caso appiattita sull’aspetto economico, mentre poco si riflette su un elemento decisivo: la crisi di un modello culturale e di imprenditoria. Diciamo subito che l’immagine della Discoteca con la D maiuscola non esiste. Il Cocoricò, nel panorama della notte è un elemento minoritario, e lo è da sempre. Hanno proliferato, al di sotto delle grandi fabbriche dello sballo notturno, migliaia di locali di media grandezza, che costituivano la vera ossatura dell’imprenditoria notturna italiana e che oggi rischiano di chiudere o hanno già tirato giù le serrande.
Al di là dei casi singoli, è un fatto che il modello di imprenditoria culturale proposto nel passato è stato, finché è durato, un modello insostenibile basato su costi elevati, ritmi folli, cachet spropositati per artisti spesso non eccezionali ma ben pubblicizzati. Quello che non reggeva era anche la proposta culturale, spesso basata sul semplice vecchio ideale di trasgressione, che altro non è che “evasione” a uso e consumo dell’estabilishment.
Un ruolo importante lo hanno avuto, dietro questo mondo, le iniziative musicali e culturali indipendenti, sommerse, prodotte in maniera spesso “illegale” e che, infatti, il Silb denuncia a gran voce arrivando, sul suo sito, a pubblicizzare con fierezza denunce e chiusure di locali “abusivi”. Tra questi, ovviamente, raver e spazi autogestiti che, in tutta Italia, hanno rappresentato per questi imprenditori della notte una spina nel fianco. Il punto è che la discussione, schiacciata sulla contrapposizione legale/illegale, è stata assolutamente inadeguata. A Napoli, in particolare dal 1991, anno di occupazione del centro sociale di Gianturco e in linea con quanto già fatto nella precedente esperienza del Tien a Ment a Soccavo, la possibilità di costruire un proprio spazio di socialità e cultura al di fuori dei circuiti ufficiali è diventata una pratica possibile, e sempre più diffusa.
All’interno dei centri sociali, come all’interno dei rave che si organizzavano un po’ ovunque in Italia, si capiva che era possibile un’alternativa al mondo delle discoteche, nella quale era possibile essere protagonisti e non fruitori passivi, ascoltando una musica diversa da quella imposta dai grandi circuiti. Si poteva, poi, pagare poco, e soprattutto partecipare all’evento fin dalla sua progettazione. Pensiamo a quanto hanno modificato l’immaginario collettivo le dancehall, eventi musicali nei quali si annulla la distanza tra dj e “pubblico” che, allo stesso piano della consolle e con microfono a disposizione di tutti, può partecipare, fare comunicazione politica o semplicemente dire la propria. Su questa scia si è assistito a un moltiplicarsi di eventi estranei ai canali ufficiali. Anzi, sono state queste proposte culturali a “infettare” i locali, influenzando la programmazione e le modalità organizzative di molti piccoli e medi club a Napoli ma non solo.
È vero che a fronte delle tasse da pagare, della Siae, delle restrizioni imposte agli esercizi commerciali i centri sociali e le realtà clandestine, come i rave o gli innumerevoli free party che si sono succeduti in Campania negli ultimi venticinque anni, si muovevano su un territorio con meno burocrazia. Ma è anche vero che mai quelle realtà si sono poste l’obiettivo di competere con i club ufficiali. E, poi, comunque, è chiaro che il problema non è quello della “concorrenza sleale”, perché ciò che si è mosso al di fuori dei locali del divertimento ufficiale aveva nel modello culturale il proprio punto di forza.
Dal Piper in poi, i club del divertimento “upper class” di un tempo si sono trasformati nelle mega discoteche che hanno ospitato migliaia di persone lungo tutti gli anni Novanta. Il regime esclusivo dei locali alla moda non poteva reggere il ritmo di un mercato in espansione che buttava sulla pista da ballo masse sempre crescenti. Ne aveva bisogno, la società dei consumi, di quelle masse, aveva bisogno che si ingrossassero, che facessero girare i loro soldi dentro un sistema spinto all’eccesso, e soprattutto aveva bisogno che stessero buoni a “spaccarsi ammerda” con la musica unza-unz, che poco spazio lasciava ai pensieri; e con le droghe sintetiche che, invece, quel poco spazio lo azzeravano del tutto.
Le discoteche sono state l’unità di produzione della società dei consumi e ne hanno riprodotto finalità e modi di funzionamento. È vero che la storia non si fa con i se, ma si potrebbe provare a chiedersi cosa sarebbe stato, di questo paese se, come auspicano i gestori dei locali italiani riuniti in associazione, fossero sopravvissuti solo loro, le aziende del divertimento che operano all’interno dei confini (in Italia sempre molto labili e mutevoli, in verità) della legalità. Se al posto delle decine di eventi selvaggi che si sono succeduti in questi ultimi decenni, ai quali hanno partecipato migliaia di persone in fuga da un modello culturale decadente, non ci fosse stato altro. Questo paese avrebbe sicuramente un volto differente. Probabilmente segnato da qualche cicatrice in più. (gaetano tessitore)
PUNTATE PRECEDENTI:
Disco devil. Un’inchiesta a puntate sul mondo delle dancefloor
Disco devil #1. Da Calvizzano a Berlino: c’era una volta la Love Parade
Disco devil #2. Chi ha paura della Tekno? I Nameless raccontano il mondo dei free party
Disco devil #3. Napoli psichedelica. Una tribù aliena nel cuore della città
Disco devil #4. Ballando fuori dalla mappa. Il Free party prima dello smartphone

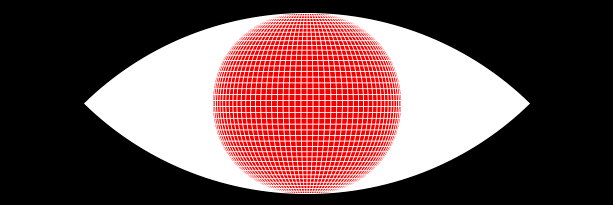

Leave a Reply